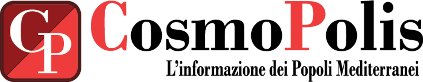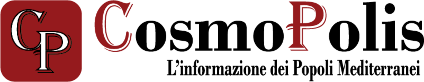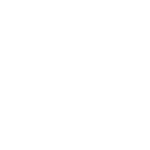di Fabrizio Guacci
Oggi, l’Occidente guarda a quelle rivolte, inizialmente accolte come segno di risveglio democratico, come ad un trauma irrisolto, natura di nuove instabilità e guerre che si riflettono su interessi economici e securitari ormai strutturali
Si avvicina il quindicesimo anniversario dell’episodio che ha dato avvio al fenomeno delle Primavere arabe: il 17 dicembre 2010, l’immolazione di Mohamed Bouazizi in Tunisia fu la scintilla della rivoluzione che sembrava poter cambiare il destino del mondo arabo. Le piazze colme chiedevano libertà e dignità, dalla Tunisia all’Egitto, dalla Siria allo Yemen, ci fu un’eco di speranza per un risveglio democratico che potesse travolgere regimi eterni. Parlarne oggi, nel 2025, sembra nuovamente un atto utopistico: quell’eco si è rivelato un amaro scenario di illusioni tradite e sogni spezzati.
Dove tutto ebbe inizio, a Tunisi, l’adozione della nuova Costituzione e le prime libere elezioni avevano fatto pensare ad un modello possibile, ma dal 2021 la situazione è precipitata nuovamente, con il presidente Kais Saied che ha sospeso il Parlamento e accentrato i poteri sulla sua persona. In Egitto, dopo la breve parentesi di Mohamed Morsi, dal 2013 il ritorno al potere militare di Abdel Fattah al-Sisi ha riportato il Paese in un clima di repressione dura. In Libia, a seguito della caduta di Gheddafi si è aperto un vuoto di potere e la triplice divisione che ancora oggi alimenta il caos nel Paese.
In Yemen, permane il conflitto che sta devastando il Paese: a seguito delle proteste cadde Ali Abdullah Saleh lasciando spazio al movimento Houthi, che nel 2014 prese la capitale Sana’a, innescando una guerra regionale con il coinvolgimento dell’Arabia Saudita. Ad oggi vi è una delle crisi umanitarie peggiori del mondo e gli Houthi si sono affermati come attori regionali, finanziati anche da attori esterni, estendendo il loro raggio di azione ai mari con obiettivo navi nel Mar Rosso e alimentando nuove tensioni globali.
La Siria rappresenta invece forse il caso più complesso, i moti pacifici del 2011 contro il regime di Bashar al-Assad sono mutati in una vera e propria guerra civile lunga e sanguinosa. Dopo la caduta di Assad nella fine del 2024 il Paese sta tentando una fragile transizione, ma le macerie sono immense: milioni di profughi bloccati ai confini, città distrutte e società lacerata da divisioni etniche e confessionali; la ricostruzione appare più una sfida geopolitica che un progetto nazionale.
Quello che doveva essere un risveglio politico si è dissolto tra autoritarismi e guerre settarie, da primavera araba si è passati ad un “inverno arabo” con le crisi che non solo non sono state risolte, ma si sono aggravate. L’instabilità ha ridisegnato gli equilibri geopolitici con gli agenti esterni sempre più influenti nelle loro aree di potere, Russia e Turchia su tutte.
Oggi, l’Occidente guarda a quelle rivolte, inizialmente accolte come segno di risveglio democratico, come ad un trauma irrisolto, natura di nuove instabilità e guerre che si riflettono su interessi economici e securitari ormai strutturali. Quindici anni dopo, l’eredità delle Primavere arabe appare come un mosaico di crisi permanenti, in cui Europa e Stati Uniti non sono spettatori, ma parte di un equilibrio fragile che continua a condizionare il loro presente politico e strategico.