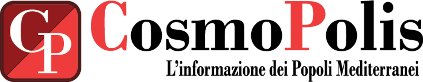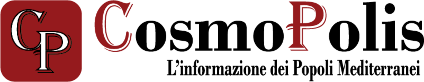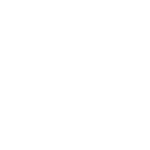di Armando De Vincentiis
Chi soffre di cleptomania vive un processo disinibitorio: ciò che nasce come pensiero si traduce subito in azione, senza che vi sia un filtro morale o di buon senso a fermarlo. In questo senso la mente non riesce a bloccare l’impulso, che diventa quasi un comando interno
Quando si parla di cleptomania, cioè di quell’impulso irrefrenabile che porta una persona ad appropriarsi di qualcosa che non le appartiene, non ci si riferisce a un furto fatto per bisogno. Non è la mancanza di denaro né la reale necessità dell’oggetto a muovere chi soffre di questo disturbo. Siamo di fronte a una condizione psicopatologica ben precisa, classificata come disturbo del controllo degli impulsi.
Chi ne soffre vive un processo disinibitorio: ciò che nasce come pensiero si traduce subito in azione, senza che vi sia un filtro morale o di buon senso a fermarlo. In questo senso la mente non riesce a bloccare l’impulso, che diventa quasi un comando interno. Molti raccontano che la tensione cresce lentamente, magari nel corso delle ore, e l’unico modo per liberarsene è proprio commettere il gesto. È come se rubare funzionasse da valvola di sfogo, simile a un ansiolitico.
Capita spesso che il primo episodio sia casuale, quasi un gioco, e che la persona nemmeno si renda conto di quello che sta facendo. Ma una volta scoperto che quell’azione porta sollievo, scatta una sorta di trappola. Il cervello registra che rubare riduce l’ansia e la tensione, e così la volta successiva ci si ritrova a inseguire di nuovo quella sensazione. In altre parole l’atto diventa un rituale: prima c’è la tensione, poi l’azione, infine la scarica e la gratificazione.
Quante volte capita di sentire qualcuno dire “Non so perché l’ho fatto, non mi serviva nemmeno”? Eppure la gratificazione non dipende dal valore dell’oggetto rubato. Conta solo la dinamica in sé, il gesto proibito, l’aver sfidato una regola e il sentirsi momentaneamente onnipotenti. Alcuni descrivono anche una scarica di adrenalina, come se la sfida con se stessi e con il rischio di essere scoperti desse una sensazione di forza.
Le cause possono essere diverse. Nella maggior parte dei casi la cleptomania si lega ad ansia, depressione o dinamiche ossessivo compulsive. In rari episodi può esserci un legame con traumi del passato, ad esempio una mancanza di affetto che il soggetto ha imparato a colmare simbolicamente appropriandosi di cose non sue, almeno secondo l’interpretazione psicoanalitica. Tuttavia non è necessario andare sempre a cercare nell’infanzia. La vera radice, più spesso, è nella dinamica ansioso ossessiva che mantiene il circolo vizioso.
La cleptomania è solo una delle tante facce di un problema più grande. Se ci pensiamo, lo stesso meccanismo ritorna in altre condizioni. Prendiamo ad esempio la piromania: chi ne soffre non appicca incendi per vendetta o per guadagno, ma perché prova un richiamo irresistibile verso il fuoco. La tensione cresce, il desiderio diventa insopportabile e l’unico modo per placarlo è accendere la fiamma, osservare le fiamme che bruciano e sentire quella scarica che per un attimo porta sollievo. È un copione che si ripete, diverso dall’esterno ma identico nella logica interna.
Lo stesso vale per il gioco d’azzardo patologico. Non si gioca davvero per arricchirsi, o almeno non è quella la spinta iniziale. Chi cade in questo vortice rincorre l’adrenalina del rischio, quella scossa emotiva che fa dimenticare per qualche istante ansia e pensieri. Il gioco è solo uno strumento, il pretesto che permette di placare la tensione. E, come nella cleptomania, l’oggetto in sé non conta.
In psicoterapia ci si concentra proprio sulla tensione emotiva. Perché non basta dire alla persona “smetti di rubare”, né colpevolizzarla per l’atto. Se non si lavora sulla tensione, sull’ansia e sulla compulsione che sta sotto, il problema si ripresenterà. La cleptomania non ha nulla a che vedere con il bisogno materiale, ma con la difficoltà a controllare impulsi che portano sollievo seppur momentaneo.