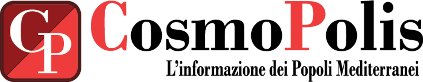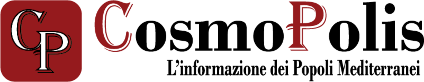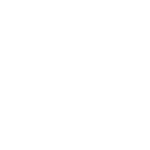di Rosa Surico
Il filosofo contadino che si cimenta nell’ antica arte della vinificazione
Vinificazione e ipogeo. Contadino e filosofo. Due binomi che aprono un varco e ne esplorano tutta la particolarità.
È conoscenza e celebrazione, un ponte tra passato e presente, quello usato anche in luogo del futuro in nuove sperimentazioni di scritture teatrali.
“Il futuro presente” che attinge però dalla memoria sacra del passato. Negli ipogei, i luoghi deputati a sepolture e luoghi di culto, la vinificazione come arte, vanta una lunga e antichissima tradizione, soprattutto in Puglia. La stessa vinificazione ha una storia vecchia quasi quanto quella del mondo.
Strutture scavate nella roccia di origine naturale e poi modellate dall’ uomo, gli Ipogei, dal greco, a indicare la stretta connessione dell’ uomo con la terra e i suoi frutti.
Ed è qui che troviamo il filosofo contadino, in un ipogeo freschissimo con angoli a cielo aperto, nell’ entroterra della provincia Jonica.
Filosofo di formazione, professore di professione e contadino per passione.
La vinificazione a settembre è per lui anche un rito di buon auspicio. Elenca con precisione tutte le fasi nel suo caratteristico ipogeo acquisito e valorizzato nel corso del tempo, già dal 1956, prima ancora da suo padre. Specifica che è coadiuvato da una tecnologia vintage, rimasta volutamente, almeno a vent’anni fa.Continua a cimentarsi con passione, è un appuntamento fisso ogni anno per sé e la sua famiglia.
La scelta della varietà dell’ uva, non è a caso.
Il Primitivo da vitigno autoctono a bacca rossa che caratterizza la vitivinicoltura pugliese.
Con minuziosa attenzione elenca e mostra tutte le fasi della realizzazione.
Dalla vendemmia, in cui si raccoglie l’ uva; si passa alla diraspatura e poi pigiatura. Vengono separati gli acini dai raspi per poi essere schiacciati; la fermentazione, dove i saccaromiceti trasformano gli zuccheri in alcol; l’affinamento, un periodo di riposo in vari recipienti e l’imbottigliamento, la fase finale che conclude il processo.
Fondamentale è la differenzazione dei due tipi di vinificazione: in rosso e in bianco, dettata dal contatto tra il mosto e le bucce (macerazione) durante la fermentazione. Nella vinificazione in rosso, le bucce rimangono a contatto con il mosto per estrarre colore, i tannini e altre sostanze che conferiscono struttura e profondità al vino. Nella vinificazione in bianco, le bucce vengono separate dal mosto subito dopo la pressatura e non partecipano alla fermentazione.
Per il filosofo contadino la vinificazione è la prova evidente dell’ ingegno dell’ uomo,della sua pazienza e capacità. A differenza della produzione dell’ olio che definisce prodotto di estrazione, il vino è un prodotto di trasformazione. Alla fine del processo non si troverà più nessuna delle sostanze, della fase iniziale.
Dai greci ai romani, la vendemmia era un momento di celebrazione e la sua riuscita era affidata alla saggezza degli anziani e ai riti in onore del Dio Bacco.
Figura di riferimento nella religione pagana dell’ impero romano , Dionisio per i greci. Divinità delle arti, dell’ agricoltura, della fertilità, del vino e del teatro. Testimone di banchetti variegati, quelli che Platone, definiva come momenti intensi in cui tutto poteva accadere.
Progettazione, condivisione, trasformazione, celebrazione della vita, invito al godimento della stessa.
Tanti i riferimenti al vino e alla vinificazione nel panorama letterario, filosofico, sociale e culturale. I due elementi sembrano onnipresenti nelle varie epoche.
Negli ipogei in particolare, la vinificazione si riveste ancor di più di un profondo significato spirituale, ma anche culturale, e affonda le sue radici nell’ utilizzo simbolico del vino. Diviene divulgatore di un messaggio di rinnovamento e rinascita che può proiettarsi al di fuori ,in epigeo, tra la gente.
L’ annata del vino inizia a settembre e che sia una buona annata quindi -si augura e augura a tutti- il contadino filosofo, quasi silenziosamente e senza mostrarsi.