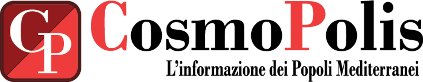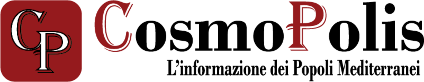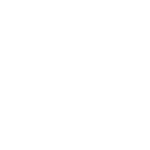di Rosa Elenia Stravato
Il rigore e la grazia: l’ estetica spartana e il suo riflesso a Taranto.Nella sobrietà di Sparta e nella fioritura artistica della sua erede italica si cela un messaggio attuale: la vera forza nasce dalla misura, e la bellezza dall’ armonia interiore
In un tempo in cui la storia ci educa a ripensare ai “corsi e ricorsi” storici, diventa fondamentale capire chi c’era prima di noi, chi ha tracciato le prime linee di un’identità collettiva fatta di orgoglio, disciplina e senso del dovere. Tra le città che più di ogni altra incarnano questa tensione tra forza e misura, tra libertà e destino, vi è Sparta — e la sua discendente mediterranea: Taranto.
Sparta non fu mai una polis come le altre. In un mondo greco che celebrava la parola, il dibattito e la bellezza, gli Spartani scelsero la via del silenzio, dell’essenzialità e del rigore. La loro società era costruita come un meccanismo perfetto al servizio della comunità: ogni individuo nasceva non per sé, ma per la polis. L’educazione spartana — l’agoghé — formava cittadini temprati alla fatica, pronti a difendere con la vita il valore supremo della patria. In questa disciplina ferrea si
nascondeva però una forma di libertà rara: quella che nasce dall’accettazione consapevole del proprio ruolo nel tutto. Sparta non insegnava solo a combattere ma a vivere con misura, a rinunciare al superfluo, a onorare la legge non come imposizione, ma come destino. Nella percezione comune, Sparta rappresenta il simbolo della severità e della negazione dell’eccesso. Eppure, proprio in
questa rinuncia si nascondeva una forma rara di bellezza: un’estetica essenziale, priva di orpelli, ma profondamente armonica. L’arte non doveva sedurre né distrarre, bensì educare. Le statue, le armi, gli edifici, perfino i canti corali rispondevano a una stessa esigenza: rappresentare l’ordine e la forza come virtù morali prima ancora che formali. La kalokagathìa — l’unione del bello e del buono — non era un ideale astratto, ma la regola quotidiana di una civiltà che faceva dell’armonia fisica il riflesso della purezza interiore. Fu una città profondamente musicale in cui vi erano le composizioni di Tirteo che scandivano il ritmo dell’addestramento e della battaglia attraverso versi brevi, potenti, destinati a unire e a infondere coraggio. La musica spartana non era evasione, ma
strumento politico. Ma Sparta, città pulsante di vita, aveva a cuore anche la danza che assumeva un
ruolo sacro e collettivo. Le danze guerresche, educavano al ritmo e alla disciplina del corpo, mentre quelle religiose celebravano la coesione della comunità. La città vedeva nella bellezza del movimento l’eco dell’ordine cosmico: la grazia era forza controllata, equilibrio in azione. Sparta, si
precisa, non costruì teatri né scolpì frontoni per la gloria, ma diede forma a un ideale di bellezza che ancora resiste: quella che non passa di moda perché coincide con la forza interiore, con la serenità dell’equilibrio, con la consapevolezza che il vero splendore non risiede nell’apparire, ma nell’essere. È in questo contesto che nasce la storia di Taranto, unica colonia fondata da Sparta in Occidente. Fu l’opera dei Parteni, i “figli senza nome” nati durante le guerre messeniche da unioni
considerate illegittime, ma che la città madre volle riscattare con un atto di fondazione. Taras sorse
sulle rive dello Ionio come un prolungamento dello spirito spartano; portò con sé l’eredità dei Dori, la lingua della disciplina e del mare. Ma al contatto con l’Italia magnogreca, quella rigidità spartana si fece più flessibile, assorbendo il gusto dell’arte, della musica, del commercio. Se Sparta rimase chiusa, Taranto si aprì; se gli spartani diffidavano del denaro, i tarantini impararono a navigare i mercati del Mediterraneo. Eppure, sotto la superficie raffinata della polis jonica, batteva sempre un
cuore spartano: quello che non dimentica il sacrificio, la misura, la dignità. La liaison tra Sparta e Taranto è più che una genealogia: è una lezione di equilibrio tra rigore e apertura. La città greca che non volle piegarsi all’oro di Atene o all’eloquenza di Corinto trovò, nella sua colonia italica, una nuova vita, più temperata ma non meno orgogliosa. E così, in un periodo in cui la misura sembra perdersi nell’eccesso e la comunità nell’individualismo, ricordare l’eredità spartano-tarantina non è esercizio di archeologia, ma di coscienza. Ci insegna che la forza di un popolo non si misura nel dominio, ma nella capacità di mantenere intatti i propri valori di fronte al cambiamento. Sparta ci lascia il mito del rigore, Taranto
la prova della sua metamorfosi. Due volti dello stesso destino: quello di chi sceglie di non dimenticare da dove viene, per sapere sempre dove andare.