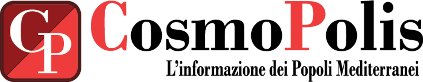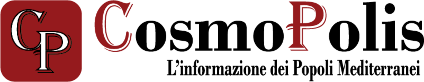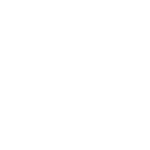di Armando De Vincentiis
La suggestione di massa, però, non nasce mai dal nulla. Di solito esiste un punto di partenza concreto, un innesco iniziale che dà legittimità all’emozione collettiva. Che si tratti di veri droni o di semplici fenomeni naturali mal interpretati, l’importante è la presenza di uno stimolo su cui costruire la tensione. A partire da quell’elemento minimo, la paura si amplifica e diventa racconto
Già secondo Il Psychology Today (“The Psychology Behind the European Drone Scare”, 2025), la recente ondata di avvistamenti di droni in Europa può essere interpretata come una forma moderna di isteria di massa, in cui paura e incertezza portano gruppi di persone a scambiare stimoli ambigui, come luci o oggetti nel cielo, per minacce reali. L’articolo descrive il fenomeno come un vero e proprio “attacco d’ansia collettivo”, alimentato da un contesto geopolitico teso, da aspettative di pericolo e dalla diffusione rapida di notizie e testimonianze attraverso i social media.
Episodi simili si sono già verificati in passato. Ad esempio nel 1942, durante il cosiddetto Battle of Los Angeles, un falso allarme aereo portò all’attivazione delle batterie antiaeree contro un bersaglio inesistente. Anche negli anni successivi si sono registrati numerosi casi di “epidemie psicogene di massa”, spesso in scuole o fabbriche, dove un singolo episodio reale o presunto ha innescato la diffusione di sintomi e reazioni collettive.
La suggestione di massa, però, non nasce mai dal nulla. Di solito esiste un punto di partenza concreto, un innesco iniziale che dà legittimità all’emozione collettiva. Che si tratti di veri droni o di semplici fenomeni naturali mal interpretati, l’importante è la presenza di uno stimolo su cui costruire la tensione. A partire da quell’elemento minimo, la paura si amplifica e diventa racconto.
Basta un minimo cenno per far scattare l’allarme: un referto, una segnalazione, una fotografia sfocata sono spesso sufficienti per innescare la catena di segnalazioni. L’effetto predominante sembra essere più quello di spaventare che quello di attivare un autentico meccanismo di sicurezza, perché la reazione collettiva viene nutrita dalla percezione stessa del pericolo più che dalla verifica dei fatti. I giornali contribuiscono a questo meccanismo quando riportano notizie senza adeguati controlli, amplificando voci e avvistamenti non verificati e trasformando un singolo episodio in emergenza pubblica e, spesso, senza nemmeno l’utilizzo del condizionale.
È in questo meccanismo che la propaganda bellica trova terreno fertile. Lo stimolo iniziale, reale o presunto, può essere trasformato in una narrazione capace di mantenere viva l’allerta, suggerendo l’idea assurda che potremmo essere attaccati da un momento all’altro. Tale percezione, ovviamente, serve a legittimare decisioni politiche e militari, come l’invio di armi e fondi, o l’aumento della produzione bellica e delle relative spese. In questa prospettiva, l’avvistamento di droni diventa un’arma simbolica necessaria, uno strumento narrativo per creare allarme, anche in assenza di prove concrete o filmati. Ciò che conta è mantenere viva la tensione se non la paura.
Il vero rischio è che il continuo ricorso a questi episodi finisca per produrre l’effetto opposto. Quando il pubblico percepisce la ripetizione e la debolezza delle prove, l’allarme può trasformarsi in una barzelletta. La paura, anziché consolidarsi, si svuota, e la narrazione perde la sua forza persuasiva. Un altro rischio, quello che ovviamente nessuno, almeno tra la gente comune, si augura , è che si possa creare davvero la cosiddetta profezia che si autoavvera. Ossia quella serie di manovre il cui scopo sarebbe quello di scongiurare un pericolo ma che, in realtà lo si costruisce. L’Europa, forse, sta giocando a mantenere un clima di guerra e si sta armando per difendersi da una minaccia fantasma senza pensare che potrebbe superare la temuta soglia critica di non ritorno e trasformare quel fantasma in qualcosa di concreto.