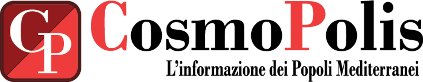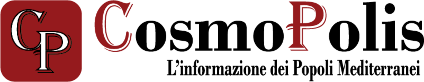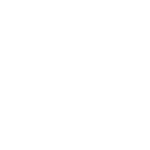Di Rosa Elenia Stravato
Con “Ninì e la balena”, l’attore tarantino riporta in scena la memoria sommersa della città: un teatro antropologico che scava nelle viscere del mito per restituire voce e dignità a Taranto e al suo mare
Che cos’è il teatro? Un luogo dove vedere uno spettacolo o il resoconto della nostra vita? In un tempo che ci vuole iperconnessi e prestanti, quanto spazio lasciamo al farci parlare? Insomma: a che serve il teatro oggi. Serve, forse, a ricordarci che siamo fatti di voce, di respiro, di carne viva e memoria. Serve a trattenere quel poco di umano che rischiamo di smarrire fra schermi e notifiche. E serve, come accade con “Ninì e la balena”, a ritrovare il filo smarrito della nostra identità collettiva, il senso di appartenenza a una terra che parla di mare e di mito, di grazia e di ferita.
Lo scorso 9 novembre 2025, il Teatro Tatà di Taranto ha accolto il ritorno in scena di Giovanni Guarino, attore, regista e narratore dell’anima tarantina.
Con “Ninì e la balena”, Guarino firma un lavoro che è insieme rito e racconto, un atto d’amore verso la sua città e un’esplorazione poetica della sua essenza più profonda. Il punto di partenza è un episodio reale, quasi dimenticato: la cattura, nel febbraio del 1877, di una gigantesca balena boreale nella rada del Mar Grande di Taranto. L’animale, spintosi per cause ignote fino alle coste ioniche, rimase intrappolato nella rada, destando stupore e meraviglia tra i pescatori e gli abitanti della città.
L’evento fece parlare a lungo di sé: una creatura venuta dal profondo Nord che approda nel cuore del Mediterraneo, come un presagio o un simbolo, della potenza del mare, ma anche della fragilità dell’uomo di fronte alla natura. Un fatto straordinario, che pare uscito da una leggenda marina, e che diviene per Guarino il pretesto per interrogare la memoria collettiva della città.
Attraverso Ninì, personaggio di confine tra realtà e sogno, l’attore dà voce a un Taranto che non si rassegna alla sua dannazione industriale, ma tenta di riconciliarsi con la propria natura profonda, quella di porto, di crocevia, di ventre del Mediterraneo.
Guarino non racconta semplicemente una storia: la evoca, la scolpisce con la parola e con il corpo, restituendo al teatro la sua funzione primigenia, quella di luogo sacro in cui la comunità si specchia e si interroga. Il suo teatro è antropologico, nel senso più alto del termine: indaga l’uomo dentro la cultura, la cultura dentro l’uomo. E in questo dialogo serrato tra mito e identità, tra rito e memoria, si avverte l’eco di un teatro artigianale alla Coupeau, dove la precisione del gesto si fonde con la spontaneità del racconto orale, e dove l’attore diventa un artigiano di emozioni, un cesellatore di umanità.
C’è, in Guarino, la sapienza di quella preziosissima disciplina che è stata e continua ad essere l’antropologia teatrale: lo studio dell’essere umano in scena, del suo comportamento “extraquotidiano”, di quella trasformazione fisica e interiore che l’attore compie quando passa dalla vita al rito della rappresentazione. È una ricerca che va oltre la tecnica, per interrogare l’origine del gesto, la memoria del corpo, la sua capacità di custodire e trasmettere cultura.
Si intravede l’aurea immensa di Jerzy Grotowski, che ha portato l’attore verso una “povertà sacra”, spogliandolo di orpelli per far emergere la verità del gesto e della voce. L’antropologia teatrale, per l’attore tarantino, rappresenta un cammino: un modo di pensare il teatro come indagine sull’uomo, sulle sue radici e sul mistero della sua presenza. È il luogo dove il fare teatrale si intreccia con la vita, e dove l’attore diventa, ancora una volta, custode di umanità.
Il palco del Tatà, spoglio e denso al tempo stesso, si trasforma in una zattera che naviga fra passato e presente, fra le onde del Mar Grande e le viscere della città. Guarino plasma la scena con pochi elementi, una sedia, un telo, la voce, ma li fa vivere come creature. Ogni suono, ogni pausa, ogni inflessione diventa un frammento di Taranto che si risveglia, un respiro che torna a farsi coro.
Ninì e la balena non è solo uno spettacolo: è un atto di restituzione. Restituzione di memoria a una città che troppo spesso dimentica se stessa. Restituzione di dignità al teatro come luogo necessario, come spazio di resistenza contro la superficialità del tempo presente.
E forse è proprio questo, oggi, il compito del teatro: non intrattenere, ma trattenere. Trattenere le storie, le voci, le radici. Trattenere la possibilità di ascoltare ancora.
Con il suo ritorno, Giovanni Guarino non offre solo un nuovo lavoro artistico: offre un gesto civile, un invito a guardare Taranto con occhi diversi. Come quella balena emersa dal fondo del mare, la città risale dalle sue profondità, e in quell’emersione c’è tutta la potenza del teatro, la sua verità, la sua urgenza, la sua eterna necessità.