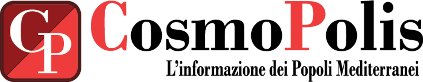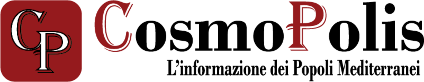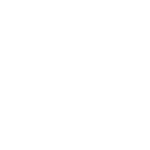di Rosa Elenia Stravato
Dal 1949 al 1952: il Premio Taranto, un faro di letteratura e arte che illuminò il Sud e che oggi meriterebbe di rinascere
Quando si rievoca la storia culturale del secondo dopoguerra, il Premio Taranto affiora come una
gemma luminosa, la cui breve esistenza – appena quattro edizioni, dal 1949 al 1952 – non impedì
che lasciasse un’impronta profonda nella letteratura e nell’arte italiane. Sorto in un’Italia che faticava a rialzarsi, il premio seppe imporsi come uno spazio di confronto, di sperimentazione e soprattutto di riconciliazione tra la città jonica e il panorama culturale nazionale. Un’eredità fulgida nonostante il tempo, talvolta, sembri voler opacizzare la freschezza e l’innovazione culturale che fu.
A colpire, ancora oggi, non è soltanto la qualità delle opere premiate o discusse, ma la densità intellettuale dei suoi protagonisti: figure che hanno segnato il Novecento e che a Taranto trovarono un crocevia fecondo, un palcoscenico capace di riceverli con un rigore e una dignità inaspettati per una realtà considerata allora periferica.
Il Premio si presentava come una kermesse capace di superare la geografia giacché il Premio Taranto fu, prima di tutto, un laboratorio. Nelle sue sale si
incontravano poeti, critici, artisti e cineasti: voci giovanissime e maestri già affermati, uniti dall’urgenza di dare forma a una cultura rinnovata. Singolare, poi, la scelta di far ruotare tutto attorno alla tematica del mare nella città che, a guardar bene, è bagnata dai due mari. Una città fatta di mare e storie, di mani sporche di salsedine e racconti disseminati tra paranze e allevamenti di cozze. Una città che, a guardar bene, si riconosce antropologicamente in quei mari.
Ambiziosa impresa, coraggiosa, si direbbe. In un Sud che spesso veniva raccontato soltanto per il suo ritardo economico, il premio dimostrò che esisteva invece una comunità intellettuale vivissima, capace di dialogare con i centri maggiori del Paese. Va detto che, eventi come questo non sono semplici celebrazioni estetiche: sono strumenti identitari. Permettono a una città – e Taranto ne è esempio eminente – di sottrarsi a narrazioni riduttive. Troppo spesso associata, oggi, alla sola
“questione Ilva”, Taranto possiede invece un patrimonio poetico e artistico che merita di essere riportato al centro. I premi culturali, soprattutto quando coraggiosi, hanno il potere di svelare ciò che i luoghi custodiscono dietro la coltre delle semplificazioni.
Il prestigio del Premio Taranto si misurò anche attraverso gli ospiti che vi presero parte, tra cui alcuni dei più grandi interpreti della poesia italiana del secolo scorso. In primo luogo, Giorgio Caproni, con la sua lingua tagliente e
pietosa, portò a Taranto una riflessione poetica tesa, altissima, già carica di quella “spietata chiarezza” che avrebbe accompagnato tutta la sua opera. Vittorio Sereni, allora voce emergente, testimoniò come la poesia potesse essere strumento di inchiesta morale, di resistenza esistenziale; il suo sguardo in bilico tra lirismo e misura civile costituì un faro per molti giovani autori del Sud.
Anche Giuseppe Ungaretti, ormai maestro riconosciuto, confermò quanto la sua parola, scavata nel
silenzio, potesse elevarsi a simbolo di rinascita. Non a caso amava ripetere: “La poesia è il mondo,
l’umanità, la vita stessa, e nasce quando il dubbio si fa musica.” Una frase che riecheggiò potentemente anche nelle discussioni tarantine. E non poteva, certo, perdersi l‘opportunità di presenziare il poliedrico Pier Paolo Pasolini, presenza magnetica e inquieta, colpì invece per la radicale fiducia nella letteratura come strumento etico. Scriverà infatti anni dopo: “La letteratura è
sempre una forma di protesta, una dichiarazione d’amore o di dolore verso l’uomo.”
Un’affermazione che sembra descrivere perfettamente la tensione di quegli incontri.
Comprendiamo, dunque, che il valore di questo spazio raccontava molto di più di una Taranto ex
colonia della Magna Grecia; era un baluardo di speranza e sperimentazione, dunque, un patrimonio
da riscoprire nei nostri giorni. Giorni caratterizzati da memorie estemporanee, da risposte preconfezionate da intelligenze artificiali e dicerie da “scrollamenti”. Se oggi il Premio Taranto si staglia come un episodio lontano, è forse perché non abbiamo ancora imparato a custodire davvero i nostri tesori culturali. Eppure, basta rievocarne la storia per rendersi conto di quanto fosse avanzato,
generoso, visionario.
La Puglia – e Taranto in particolare – continua a essere terra di scrittori, poeti, illustratori, drammaturghi, musicisti: un mosaico di talenti che chiede soltanto un contesto adeguato per emergere. In un’epoca che sembra aver ritrovato il desiderio di festival e di rassegne letterarie, nulla vieta di sperare che il Premio Taranto possa tornare in auge, rinascere con una formula
contemporanea ma fedele allo spirito originario: essere un ponte tra le generazioni, uno spazio di incontro, un atto d’amore verso la parola e verso la città. Rimettere in vita quel premio significherebbe restituire a Taranto una parte della sua storia migliore. E, forse, permetterle di tornare a essere ciò che un tempo fu, anche solo per quattro anni: un faro nel panorama culturale italiano.