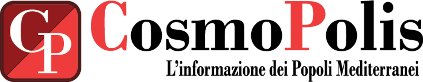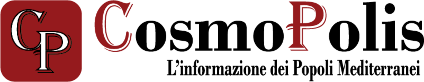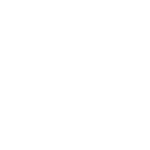di Rosa Elenia Stravato
Scrittore, giornalista, testimone del Sud: l’eredità intellettuale e civile di un uomo che ha dato dignità alla sua Taranto e ai suoi margini
Ci sono persone che passano sulla nostra Terra come meteore capaci di lasciare un segno che profuma di eternità. Pochi autori italiani contemporanei, infatti, hanno saputo osservare e descrivere con dovizia e rigore le contraddizioni del nostro Paese. Penne capaci di restare fedeli ad uno stile inconfondibile, che hanno saputo tessere trame realissime con lucidità e profondità.
Alessandro Leogrande, nato a Taranto nel 1977 e scomparso prematuramente nel 2017 è quella meteora che ha reso a parola il traghetto per restituire al mondo uno sguardo vigile sulla sua Taranto. La sua opera, per vastità di temi e coerenza morale, rappresenta oggi uno dei più alti esempi di giornalismo narrativo italiano, una bussola per chi desidera comprendere la realtà senza accontentarsi delle sue superfici.
Cresciuto tra splendore marino e ombre industriali, Leogrande sviluppò presto una sensibilità attenta ai luoghi marginali e alle vite fragili; trasferitosi a Roma per gli studi universitari, cominciò a collaborare con diverse riviste fino a diventare vicedirettore della storica testata Lo Straniero, diretta da Goffredo Fofi. Le sue inchieste, i suoi reportage e i suoi libri — tra cui Uomini e caporali, Il naufragio, La frontiera — hanno portato alla luce fenomeni spesso ignorati: lo sfruttamento dei braccianti, le rotte dei migranti, le ferite sociali di interi territori traditi da politiche miopi. Leogrande non era un semplice cronista. Era un intellettuale che praticava un’autentica pedagogia dell’ascolto, convinto che solo osservando gli ultimi si potesse comprendere la verità del nostro tempo.
La sua? Un’etica della complessità delle contraddizioni. Un’attenzione, la sua, alla complessità, un valore che oggi più che mai sarebbe necessario indagare con quella franchezza di cui lui era portatore sano. Non cercava scorciatoie, non semplificava, non cedeva all’ideologia. Analizzava fenomeni difficili — le migrazioni, la globalizzazione, lo sfruttamento del lavoro — con rigore e compassione.
Al centro della sua opera c’era l’idea che la letteratura e il giornalismo potessero essere strumenti di trasformazione civile, purché mossi da un sentimento di responsabilità. Leogrande credeva nella potenza del racconto come atto politico: narrare significava restituire dignità, illuminare ciò che resta nascosto, dare voce a chi non ne ha.
Tra tutte le sue battaglie civili, quella per Taranto fu la più intima. Taranto era la sua origine, la sua ferita e il suo orizzonte. Nei suoi articoli e nei suoi interventi pubblici analizzò con chiarezza la tragedia della città: un territorio sacrificato sull’altare dell’industria, diviso tra la necessità del lavoro e il diritto alla salute.
Leogrande raccontò Taranto senza retorica, mettendo in dialogo memoria storica, responsabilità politica e sofferenza quotidiana. La sua era una denuncia priva di rabbia sterile, ma ricca di un amore vigile, l’amore di chi desidera vedere la propria città risorgere attraverso la consapevolezza. La sua voce, rispettata e ascoltata, contribuì a far emergere un dibattito nazionale sul futuro del territorio jonico. Ancora oggi a Taranto il suo nome non è soltanto un ricordo: è un simbolo di coscienza civile, una promessa di attenzione verso chi vive ai margini dei processi decisionali.
L’opera di Leogrande è fondamentale non solo per ciò che racconta, ma per come lo racconta. In un tempo dominato dalla velocità e dalla superficialità, egli ha mostrato il valore della lentezza, dello studio, dell’indagine approfondita. Ha insegnato che la realtà è fatta di strati, e che comprenderla richiede pazienza e cura.
Grazie ai suoi libri oggi possediamo una mappa etica-civile del nostro presente: un archivio di storie che interroga, commuove, inquieta. La sua scrittura è un invito a prendere posizione, a non distogliere lo sguardo, a riconoscere l’umanità altrui come condizione della nostra stessa umanità. La sua scrittura può, forse, essere un monito a non appassire. A non vivere in maniera asettica, a cercare la propria strada anche quando sarebbe più semplice scendere a compromessi. Nessun lirismo, orpello: la possibilità di raccontare quello che è il mondo per scuoterlo, magari, salvarlo dal delirio dei ripetuti ed ostinati “così deve andare”.
Per onorare la sua memoria e proseguire la sua missione, è stato istituito il Premio “Alessandro Leogrande”, dedicato a chi, attraverso la scrittura, il giornalismo o la ricerca sociale, porta avanti un’idea di racconto fedele allo spirito del suo lavoro. Il premio nasce con una duplice funzione: da un lato custodire l’eredità di Leogrande, mantenendone vivo lo spirito e lo sguardo sulla complessità del reale. Dall’altro, promuovere nuove voci capaci di indagare i lati oscuri della contemporaneità con onestà intellettuale e rigore morale. Non si tratta, quindi, di una semplice commemorazione. È un ponte verso il futuro, uno strumento per continuare a generare consapevolezza, per alimentare quella cultura dell’impegno che Leogrande incarna in modo esemplare.
La scomparsa di Alessandro Leogrande a soli quarant’anni ha lasciato un vuoto profondo nel mondo culturale italiano. Eppure, la sua presenza continua: nei suoi libri, nelle testimonianze dei lettori, nelle storie che ha raccolto e restituito al Paese. Continua soprattutto a Taranto, dove è ricordato come un figlio che non ha mai smesso di interrogare la propria città, e come una coscienza che invita ancora oggi a non rassegnarsi. Oggi è necessario parlare di questo grande uomo perché rappresenta la possibilità di guardare il mondo con occhi aperti, empatia e rigore; dare ascolto a chi non viene ascoltato; credere che la narrazione sia uno strumento di giustizia. Alessandro Leogrande non c’è più, ma la sua voce — lucida, coraggiosa, profondamente umana — continua a indicarci la strada.