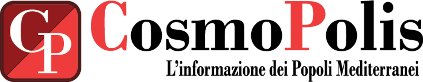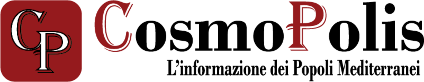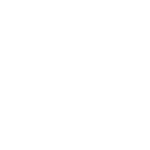di Rosa Elenia Stravato
Analisi critica di una ricorrenza simbolica che mette in luce il divario tra denuncia, intervento e una cultura patriarcale ancora troppo radicata in Italia
Il 25 novembre non è un giorno qualunque: è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma dietro l’apparente rituale della “giornata simbolica” si nasconde una voragine di inazione, di mancate risposte strutturali, e un pericoloso silenzio culturale che rende la ricorrenza, in molti casi, una semplice ombra su drammi reali. L’individuazione fu adottata dalle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, in memoria delle tre sorelle Mirabal – Patria, Minerva e María Teresa – uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana per ordine del dittatore Trujillo. Le tre erano attiviste politiche, simbolo di resistenza, e il loro assassinio suscitò indignazione internazionale.
Questo giorno rievoca il senso di un attivismo femminista latinoamericano datato 1981, quando, durante il primo incontro femminista latinoamericano e caraibico a Bogotá, venne deciso di onorare le Mirabal istituendo proprio il 25 novembre come giornata di lotta. Non è solo memoria: è mobilitazione globale. La violenza contro le donne, lo sentiamo abitualmente, non è un incidente isolato ma un meccanismo sistemico, radicato in disuguaglianze di genere che affondano le radici in secoli di supremazia maschile. La Dichiarazione delle Nazioni Unite, definisce tale tipologia di violenza come “ogni atto di violenza fondata sul genere” che causa danno fisico, sessuale o psicologico e può avvenire nella vita privata o pubblica. In Italia – e non solo – questa violenza si manifesta in molte forme: maltrattamenti, abusi sessuali, coercizione, stalking, violenza economica, psicologica, fino al femminicidio. Frasi come “sei mia” rappresentano uno dei primissimi campanelli d’allarme. Se l’attenzione è spostata ai dati nazionali, resteremo scioccati. Il 31,5% delle donne in Italia ha subito nella vita almeno una violenza fisica o sessuale. In media, negli ultimi anni, si registra un totale di 336 omicidi, con un tasso pari a 0,58 per 100.000 abitanti. Le chiamate al numero verde antiviolenza 1522 sono aumentate in modo drammatico. Eppure, direte, siamo iper stimolati e sensibilizzati a questa “questione”. Ma allora come si spiegano questi dati? Essi ci mostrano mostrano chiaramente un gap tra la richiesta di aiuto da parte delle vittime e la loro piena protezione: le vie d’uscita non sono né facili né scontate.
Le denunce esistono, ma l’accompagnamento è lento, i percorsi di protezione sono fragili, il ritiro delle denunce testimonia buona parte del problema: paura, mancanza di risorse, isolamento. Negli ultimi anni l’Italia ha adottato misure rilevanti, ma il contrasto alla violenza di genere non è solo una questione di pena: è questione di prevenzione, cultura, strutture di supporto. Una “legislazione speciale” non significa necessariamente solo punizione più severa, ma un quadro normativo che rafforzi la protezione preventiva, la specializzazione procedurale, la formazione, la prevenzione sociale. Il Codice Rosso è il fulcro della legislazione recente contro la violenza domestica e di genere. Introduce nuove fattispecie di reato (come il “revenge porn”, la deformazione permanente del viso, la costrizione al matrimonio) e inasprisce le pene per maltrattamenti, stalking, violenza sessuale. Legge di riforma del processo penale (legge n. 134/2021) ha esteso le tutele anche alle vittime di tentato omicidio domestico o di genere e si coniuga alla Legge n. 53/2022 che ha teso potenziare la raccolta dati statistici sulla violenza di genere, migliorandone il monitoraggio. Fondamentale è stata l’approvazione della Legge 24 novembre 2023, n. 168 che ha rafforzato le misure preventive e cautelari come l’estensione dell’ammonimento del questore, l’obbligo informativo da parte di forze dell’ordine e istituzioni, misure di prevenzione più incisive (anche braccialetto elettronico per indiziati), la formazione degli operatori nonché risposte più rapide nelle fasi cautelari e processuali. Nonostante queste leggi, non sempre la applicazione funziona bene giacché la formazione è disomogenea, in molti territori mancano risorse adeguate, i centri antiviolenza sono spesso sottofinanziati.
Vige una diffusa idea di una sorta di cultura di impunità che stenta a morire. Il deterrente culturale è debole e la semplice repressione non risolve il problema. Serve, quindi, una legislazione strutturale, non solo emergenziale: misure integrate che uniscano diritto penale, sostegno sociale, prevenzione educativa e un vero piano nazionale contro la violenza di genere. Forse andrebbe ponderata, strutturata, una vera e propria cultura di prevenzione con misure “spia” di reato e un approccio che non è solo punitivo, ma preventivo, che cerchi – quindi- di costruire un’efficace rete di allerta e protezione. I Centri antiviolenza sono cruciali, ma non riescono e non possono garantire che tutte le donne escano davvero libere dalla violenza. Le Case rifugio, pur in crescita, coprono ancora solo una parte delle richieste reali, e il tasso di copertura è molto basso. Inoltre, si registra una discrepanza tra il numero di abusi denunciati, le chiamate al 1522 e le aggressioni fatali: la violenza sembra non conoscere limiti, e il sistema spesso reagisce quando ormai è troppo tardi. Non si può parlare di tutto ciò, chiaramente, se non si legge la genesi della sua origine. Per secoli la nostra società è stata plasmata da un’idea fallocentrica di potere — un ordine simbolico in cui l’uomo è soggetto, misura e “proprietario” delle proprie relazioni affettive e sessuali. In quest’ottica, la donna è spesso vista come proprietà, obiettivo, sede di desiderio ma anche di controllo. Le forme di violenza non sono semplicemente atti criminali isolati: sono manifestazioni di un modello di identità maschile costruito sulla dominazione e sulla dipendenza affettiva. Questo modello legittima la coercizione, la sopraffazione, la negazione del consenso.
Storicamente, fino a pochi decenni fa, atti violenti contro la donna potevano essere giustificati con il “delitto d’onore”. Anche se oggi il quadro legislativo è cambiato, le radici culturali rimangono profonde. Il 25 novembre non basta. Serve un salto di paradigma: non basta celebrare una giornata, bisogna riformare il modo in cui le nuove generazioni imparano a vivere le relazioni affettive. L’educazione affettiva (e sessuale) dovrebbe essere integrata nei percorsi scolastici, non come optional, ma come materia cruciale: per insegnare il rispetto, il consenso, la negoziazione, il riconoscimento dell’altro come pari. Senza un cambiamento culturale radicale, i numeri continueranno a salire o a stabilizzarsi su livelli inaccettabili. L’educazione affettiva non è un lusso: è una necessità vitale per prevenire la violenza, smantellare stereotipi, e costruire relazioni sane. Il 25 novembre non può essere una giornata “di facciata”, un rituale che placa la coscienza collettiva senza incidere davvero. I numeri parlano chiaro: la violenza sulle donne in Italia è una ferita aperta, non un capitolo chiuso.
Denunciare è fondamentale, ma non basta: serve un impegno sistemico — politico, culturale, educativo — per colmare il divario tra richiesta di aiuto e risposta concreta. Se davvero vogliamo aggirare il meccanismo perverso della violenza di genere servono leggi forti, integrate, strategiche. Non serve una giornata simbolica, non basta un inasprimento punitivo: urge una visione di lungo termine. Se non trasformiamo la simbologia in azione, il 25 novembre rimarrà una data simbolica, non un punto di svolta. Se davvero vogliamo eliminare la violenza, non basta illuminare monumenti di arancione, fare corsette e discorsi preconfezionati: serve illuminare le menti.