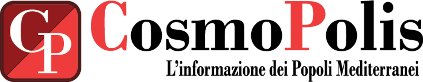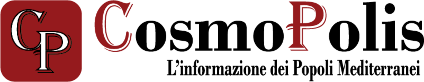di Rosa Elenia Stravato
Ritratto della straordinaria interprete martinese che trasformò il violino in un altare di rigore, pensiero e destino
Nel panorama della grande interpretazione violinistica del Novecento, il nome di Gioconda De Vito, nata a Martina Franca nel 1907, riecheggia come un enigma luminoso. Una presenza magnetica, quasi ascetica, che seppe imporre un’idea dell’arte musicale fondata su un’intransigente fedeltà alla verità interiore dell’opera. Non fu soltanto una virtuosa dello strumento – categoria che per lei conteneva già un implicito sospetto – ma un’intellettuale sibillina, capace di scolpire il suono come fosse parola sapienziale, come fosse giudizio. La sua biografia, la sua poetica e la sua produzione artistica compongono un’unica trama: quella di una donna che fece del violino non un mezzo, ma una forma di esistenza, un modo di stare al mondo senza concessioni, senza compiacimenti, e soprattutto senza paura di sparire quando avesse percepito l’avvicinarsi dell’ombra.
Una vita, la sua, devota alla perfezione; il talento di De Vito esplose precocemente: ancora adolescente affrontava pagine ardue con un’autorità quasi inquietante, come se il violino non fosse uno strumento esterno, ma un’estensione organica del suo pensiero. Dopo studi rigorosi e una rapidissima affermazione nei principali centri musicali italiani, approdò alle grandi sale internazionali, dove si impose non come giovane promessa mediterranea ma come sovrana di un’interpretazione solenne, altissima, lontana dalla facile seduzione del virtuosismo scintillante. La Londra del secondo dopoguerra fu il palcoscenico che consacrò definitivamente la sua grandezza: lì, davanti a orchestre e direttori tra i più autorevoli, De Vito mostrò quella che sarebbe stata ricordata come la sua cifra assoluta – una tensione morale del suono, una purezza quasi scultorea delle linee, una capacità di tenere la sala sospesa tra l’oscurità e la rivelazione. I più grandi direttori dell’epoca la vollero come solista; eppure, proprio nel momento di massima gloria, già si scorgeva in lei un atteggiamento appartato, una sorta di nobiltà refrattaria ai clamori. Negli anni Sessanta, in un gesto che sembrò a molti incomprensibile ma che doveva apparire a lei inevitabile, interruppe la propria carriera pubblica, scegliendo un ritiro silenzioso e irrevocabile. Non fu un cedimento, bensì un atto di coerenza: quando la perfezione le parve non più raggiungibile, preferì il silenzio all’imperfetto, il ritiro alla consuetudine. Morì nel 1994, lasciando dietro di sé una manciata di incisioni leggendarie e un’aura che il tempo non ha scalfito. La riflessione di Gioconda De Vito sulla musica – espressa attraverso interviste rare, frammentarie, quasi prelevate da un altrove – ruota intorno a un’idea centrale: la musica richiede verità, e la verità richiede sacrificio. Non sopportava l’ostentazione, la manualità prodigiosa fine a se stessa, la smorfia egotica dell’interprete che impone la propria personalità alla partitura. Per lei il violinista era un tramite, un ponte fragile tra la volontà del compositore e l’ascoltatore. Ma un tramite consapevole, armato di tecnica adamantina e di un senso quasi religioso del dovere artistico. In un tempo storico che idolatrava la velocità, la prodezza e l’esibizione, il suo pensiero suonava come un monito: l’arte non è un palcoscenico per l’io, ma una prova di umiltà davanti al mistero del suono. Era convinta che esistesse una sola forma di libertà nell’interpretazione: quella che nasce dalla disciplina estrema, dalla rinuncia al superfluo, dalla lettura intima e sofferta dello spartito. Anche la decisione di ritirarsi dalla scena rispondeva a questa logica ferrea: quando si accorse che la sua idea di perfezione non poteva più essere realizzata con la stessa ferocia interiore di un tempo, preferì tacere. Quel silenzio, più eloquente di mille concerti, divenne il gesto filosofico culminante della sua vita artistica. La sua gloria è un’eredità sobria ma incandescente. Il corpus di registrazioni lasciate da De Vito non è vasto; ma ogni incisione è un monumento. I capisaldi del repertorio violinistico – Bach, Beethoven, Brahms – nelle sue mani diventavano territori di epica severità. Nulla era “ornato”, nulla superfluo: ogni frase era costruita come un periodo classico, levigato sino a diventare puro senso.
Il suo Brahms, in particolare, rimane un riferimento quasi liturgico: un intreccio di forza e meditazione, di vigore e oscurità, che ancora oggi appare insuperato per profondità emotiva e per nitore architettonico. Nei concerti beethoveniani emergeva invece una sorta di energia tellurica, domata però da una razionalità tagliente, quasi filosofica. Bach, infine, le permetteva di esprimere la sua natura più raccolta: un dialogo serrato con l’Assoluto, un’audacia spirituale resa con una sobrietà che lascia senza fiato. Che la sua discografia sia limitata non è una perdita, ma una lezione: De Vito incise solo ciò che riteneva necessario, e solo quando sentiva di poterlo fare con completezza morale. Ogni suo gesto, anche discografico, è impregnato di quella stessa intransigenza che ne definì l’intera esistenza. Una cosa appare certa: Gioconda De Vito non fu soltanto una violinista. Questa donna fu un pensiero incarnato, un suono che si faceva etica, una donna per la quale l’arte non era spettacolo ma destino. In un’epoca che tende a consumare rapidamente ogni gloria, la sua figura resiste come una fiamma verticale e intransigente, un richiamo severo a ciò che la musica potrebbe ancora essere: un atto di verità, di misura e di coraggio. E soprattutto un luogo dove il silenzio, quando è meritato, può valere quanto la più sublime delle note.