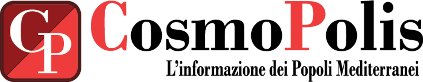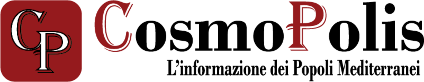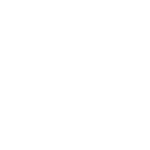Storia di una deriva politica e culturale delle nostre classi dirigenti. Di un dibattito finto. Adulterato. Del merito e della competenza sacrificate per far posto all’ipocrisia e all’arrivismo edonista. La malattia senile delle nostre democrazie rischia di relagarci nel tempo dell’indistinto
Esiste una relazione tra la sinistra – e il progressismo come variante politico-culturale – e il populismo? Quando parliamo di populismo ci muoviamo nel campo delle dottrine propriamente dette o indichiamo una prassi, un metodo, una relazione assai singolare che si instaura tra popolo e governanti? Un rapporto che miri ad esaltare valori, desideri, frustrazioni e sentimenti collettivi? Il tema risulta essere assai complesso. E per nulla nuovo ed inconsueto come una certa pubblicistica sarebbe incline a far credere, per amore delle mode contemporanee. Trasversale e non confinabili in singoli – e angusti – ambiti di riferimento. Non siamo in presenza di una novità, insomma, degli ultimi decenni. Anzi, al contrario, replichiamo ragionamenti ed analisi piuttosto datati, che ci arrivano da un passato remoto. Il populismo spesso viene considerato il polo opposto di una cultura (politica) di stampo riformista. La ricetta semplicistica a problemi complessi. La deriva di un modello partitico discioltosi come neve al sole, anche, se non soprattutto, per le novità instauratesi con la rivoluzione digitale. Il punto attorno al quale rischia di avvitarsi la democrazia.
Ma chi soni i populisti? E quando possiamo definire, con ragionevole certezza, di essere al cospetto di una politica populista? “Le democrazie liberali – scrive Francis Fukuyama – del mondo reale non sono mai state pienamente all’altezza degli ideali di libertà e di uguaglianza che ne costituivano le fondamenta. I diritti vengono spesso violati; la legge non si applica mai allo stesso modo ai ricchi e potenti e ai poveri e deboli; i cittadini, pur disponendo della possibilità di partecipare alla vita pubblica del proprio Paese, spesso se ne astengono. Esistono poi anche conflitti interni agli obiettivi di libertà e uguaglianza: una maggiore libertà spesso comporta una crescente disuguaglianza, mentre gli sforzi per parificare i risultati riducono la libertà”. Il populismo diviene la risposta di un fallimento altro. La fuoriuscita dal sistema perché lo stesso sistema non ha saputo offrire risposte adeguate. Non ha saputo, insomma, essere all’altezza dei compiti che la Storia ha assegnato ad esso. Gli esempi di leader populisti, a tal proposito, sono diversi. Collocati, senza sostanziali novità, tanto a destra quanto a sinistra. In Europa così come in altri ambiti geografici.
L’esempio storico più citato di una politica dichiaratamente populista è quello riferibile a Juan Domingo Peròn, in Argentina. Più volte presidente del Paese sudamericano, il generale diede vita al culto della personalità. La sua, naturalmente. Il peronismo rappresentò, per grandi linee, una prassi di governo “allegra” sui temi economici, all’insegna di un patriottismo esasperato, gravida di slogan, di conservazione del potere, di promesse non mantenute. Leader populisti sono anche Hugo Chavez (Venezuela) e Rafael Correa (Ecuador), per restare al continente latino-americano. Mirek Topolanek (Repubblica Ceca), Racep Erdogan (Turchia), Vladimir Putin (Russia), Giuseppe Conte e Matteo Salvini (Italia) per citare invece esempi riconducibili ad un’idea ampia di Europa. Donald Trump, nel caso della più grande – ed influente – democrazia al mondo: gli Stati Uniti. Filo conduttore di queste esperienze diverse eppure eguali, è il forte nazionalismo che fa da contraltare, cornice, alla proposizione politica. Nazionalismo che, unitamente alla variante religiosa, possono essere visti come una forte opzione della politica populista. Identitaria, secondo alcuni studiosi. Entrambe le sfere forniscono un’ideologia che spiega perché la gente si sente sola e confusa. Entrambe esibiscono una condizione di vittime che dà la colpa delle situazioni infelici di un individuo a gruppi esterni. Entrambe, infine, rivendicano il riconoscimento della dignità in modi restrittivi: non per tutti gli esseri umani ma per membri di uno specifico gruppo nazionale o religioso. E’ probabile che il nazionalismo sia stato lanciato inizialmente dall’industrializzazione, ma poi non è affatto sparito dalla terra, neppure in quei Paesi che ormai sono industrialmente sviluppati da generazioni. Il populismo è divenuto parte del dibattito politico e culturale, nelle caratterizzazioni per lo più negative che di esso danno commentatori e studiosi, ma anche nelle rivendicazioni dei suoi principali esponenti. Che questa fosse “l’età del populismo” del resto lo aveva già conclamato Ivan Krastev nel 2011.
Tuttavia, se il populismo ha specifici caratteri, cosa lo spinge? Cosa ne determina il successo? Da cosa muove? Il fenomeno populista, come detto, non è cosa nuova, anche nelle sue accezioni contemporanee: al di là dei paesi latino-americani, dove ha avuto tratti specifici, negli ultimi cinquant’anni in Europa diversi movimenti e partiti si sono affacciati sulla scena con spiccate connotazioni populiste, rivendicando soluzioni con variabile grado di demagogia per le situazioni di disagio sociale che venivano presentandosi. In vari Paesi europei, ad esempio, già dagli anni Ottanta emersero varianti populiste “esclusiviste” di destra, facendo leva sul malcontento nei confronti degli immigrati e delle minoranze nazionali. Ma vi sono stati anche diversi movimenti di sinistra con accenti populisti, negli anni recenti, come in Grecia, Italia e Spagna. Il populismo, in sostanza, non deve più essere trascurato come fenomeno minoritario, che fa leva sul malcontento, perché non solo attecchisce ma prospera e si fa minaccioso. Eppure, è da più di un decennio che i partiti populisti sono stati descritti come in aumento, con un senso di pericolo crescente e un’influenza del discorso populista non limitata ai concorrenti politici, ma estesa anche ai media e ai commentatori. Come molti analisti sostengono, il populismo si è lentamente – e progressivamente – portato dai margini al mainstream della politica europea e mondiale.
I partiti populisti di sinistra, in questo scenario, sono quelli che hanno combinato temi politici tradizionali del progressismo inteso in senso lato con una retorica e un discorso politico tipicamente populista. La retorica del populismo di sinistra consiste spesso in movimenti antielitari, di opposizione all’establishment, di rivolta della “gente comune”. Temi importanti per i populisti di sinistra sono l’anti-capitalismo, l’anti-globalizzazione, la giustizia sociale, il pacifismo, mentre l’ideologia delle classi o il socialismo, i cosiddetti diritti sociali, non sono tanto importanti quanto per i tradizionali partiti di sinistra. Paesi diversi in tempi diversi, sempre più spesso negli ultimi anni, hanno assistito all’ascesa di partiti populisti differenti, chi presentandosi come “anti-casta” e “anti-elite” o “sovranista” e “nazionalista”, chi sostenendo questioni diverse come l’ecologismo, i beni pubblici gratuiti, la “democrazia diretta” contrapposta alla rappresentazione elettiva, i confini chiusi contro gli immigrati, “No euro” e “No UE”. Ogni Paese sembra aver avuto il proprio brand di populismo, con una combinazione di questioni locali e nazionali. In tutti i casi si rileva un’opposizione all’establishment che ha attirato i populisti, coagulando il loro consenso attorno allo scontento, colorando i loro argomenti con quella tinta di rivolta che si è dimostrata efficace nel colmare il vuoto ideale, il buio di prospettiva lasciato aperto dalla morte delle cosiddette ideologie.
In tempi caratterizzati da crisi economiche, sconvolgimenti sanitari, rivoluzioni tecnologiche, cambiamenti internazionali e geo-politici, i partiti tradizionali hanno adottato posizioni politiche che, in definitiva, non hanno trovato il sostegno del proprio elettorato tradizionale, non soddisfacendone le domande. Considerati alla stregua dell’establishment, quegli stessi partiti sono stati sfidati dalle risposte confuse, seppur semplicistiche, fornite dal populismo, che, quasi per definizione, ha prospettato soluzioni facili a problemi complessi anche quando ritenute ovvie – ed illusorie – scorciatoie.
Il populismo, quindi, malattia senile – o infantile – della democrazia? Marco Revelli, a tal proposito, argomenta: “Il populismo è malattia infantile delle democrazie quando i tempi della politica non sono ancora maturi. E’ malattia senile, invece, quando i tempi della politica sembrano essere finiti”. In ambedue i casi qualcosa nel meccanismo di rappresentanza sembra essersi inceppato, interrotto. Norberto Bobbio aveva arguito che un movimento populista, dopo essere andato al governo di un Paese, “tende a spostarsi verso forme istituzionali e di riorganizzazione politica dello Stato che cambiano, sino a frantumare, la democrazia costituzionale”. Se è vero che per sua natura il populismo ha bisogno di messaggi semplici e di facile presa, era inevitabile che fosse quello identitario, intriso di nazionalismo, sovranismo e contro gli immigrati, cioè il populismo di destra, ad avere forza più duratura di quello di sinistra – cioè di classe – che chiede più giustizia sociale, più equa distribuzione, più opportunità. Il populismo di destra ha saputo indirizzare la domanda proveniente dai ceti rimasti più indietro e più in basso verso un obiettivo diverso, convincendoli che il problema non sono le disuguaglianze, ma che “non siamo padroni in casa nostra.
La destra, specie quella più nostalgica, i cui valori appaiono superati dal tempo, per così dire antimoderna, è come se si ponesse in scia al populismo. La sinistra ci arriva più per disperazione, per un atto di emulazione, che per intima convinzione. Ragion per cui spetta alle forze del campo progressista tirarsi fuori da questa dinamica angusta, liberarsi della camicia di forza che rischia di ottunderne passato e prospettive. Il populismo si sconfigge con la competenza, con la fatica dei ragionamenti lunghi, con la perseveranza dei valori nobili. Compiti che la Storia ha da sempre assegnato ad una sinistra gradualista e riformista.