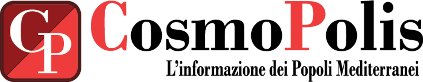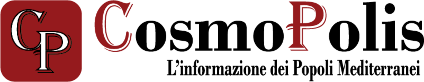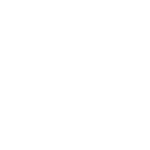di Erasmo Venosi
Il programma GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, mette a disposizione 5 miliardi di euro. Potevano essere destinati per l’ex Ilva. Ma, con questa classe dirigente, programmare il futuro diviene un’eresia
La Commissione europea, Corte di Giustizia Europea, otto governi, parlamento europeo ed italiano, Corte Costituzionale, Regione Puglia. il Tribunale di Milano e la Procura della Repubblica di Taranto: tutti questi organismi, con funzioni differenziate sono, responsabili della mancata soluzione della questione “ex Ilva di Taranto oggi Acciaierie d’Italia”. Un irrisolto rebus che dura da tredici anni.
Tredici anni di conflitti, tra il diritto costituzionale di tutela della salute e quello dell’impresa. A tale proposito è dirimente l’articolo 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
Tutte le azioni poste in essere avevano come obiettivo il bilanciamento impossibile tra valori oggetti di tutela costituzionale. Il primo atto della magistratura risale al 2012 con il sequestro degli impianti Ilva di Taranto. Nel 2012, anno del primo sequestro degli impianti dell’ex-Ilva di Taranto per proteggere l’aria, le falde e il territorio circostante, era chiaro a tutti che, per uno stabilimento altamente inquinante costruito negli anni Sessanta, non ci fossero le condizioni per proseguire l’attività secondo i canoni produttivi tradizionali. Poi un profluvio incessante di norme, di deroghe spesso al codice ambientale comprese le riduzioni delle sanzioni penali.
Sul piano finanziari soldi per cassa integrazione ed erogazione di prestiti a Ilva. Spenti quattro altoforni e il quinto da sedici giorni è in manutenzione straordinaria. Ma come poter giudicare uno Stato che ha prodotto un “ Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto” considerata, maggior fonte inquinante nella città di Taranto, con emissioni in deroga oltre i limiti di legge e la zona della città ionica era stata già dichiarata “area ad elevato rischio di crisi ambientale” sin dal 1990.
Interventi realizzati? Non tutti. Da dieci anni la ex Ilva è in amministrazione straordinaria e si è tentato di venderlo. Ora si è in cerca di un imprenditore che lo compri e realizzi la cosiddetta decarbonizzazione attuata con forni elettrici e impianti per produrre il cosiddetto preridotto. Tecnicamente si definiscono hard to abate i settori difficili da decarbonizzare, a motivo delle tecniche, dei combustibili utilizzati, l’indisponibilità di tecnologie o l’inaccessibilità dei costi per l’abbandono delle fossili impiegate.
Tra le industrie, quella dell’acciaio è la più hard to abate. L’investimento stimato per fare la vera decarbonizzazione, ovvero fonti rinnovabili e idrogeno, costerebbe 11 miliardi di euro. Ma il piano governativo prevede gas naturale liquefatto e l’investimento è dimezzato. Comunque a Taranto le norme europee, per esempio la direttiva 2024/1785 che ha modificato quella precedente 2010/75, è stata più volte violata nello stabilimento.
Ora la situazione a Taranto si è verificata anche negli altri stabilimenti del gruppo Genova Cornigliano in Liguria, Novi Ligure e Racconigi in Piemonte, Marghera in Veneto. I Sindacati giustamente sono in agitazione.
Come si può presentare un piano con otto slide senza alcun riferimento su chi rileverà lo stabilimento ma solo dando indicazioni su cassa integrazione e blocco impianto di cokefazione. Intanto per i successivi 12 anni previsti dall’AIA le sei milioni di tonnellate saranno prodotte con il carbone. Intanto si attendono il pronunciamento del TAR Lecce sull’Aia impugnata e del Tribunale di Milano.
Oggi il governo ha deciso di prolungare l’agonia della ex Ilva che perde 2 milioni di euro al giorno approvando il decreto legge che contiene misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive degli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere compensazioni al territorio. Si autorizza l’utilizzo dei 108 milioni residui del finanziamento ponte e indispensabili per garantire la continuità degli impianti fino a febbraio 2026, data in cui è attesa la conclusione della procedura di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario. I 92 milioni che restano sono destinati a interventi sugli altiforni, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, agli investimenti ambientali per il rispetto delle prescrizioni nuova Aia e al Piano di Ripartenza. Altri 20 milioni per 2025-2026, per trasferire sullo Stato l’integrazione fino al 75% del trattamento di Cassa Integrazione straordinaria finora sostenuta direttamente dalla azienda.
Si interviene anche sul Fondo per gli indennizzi ai proprietari di immobili del quartiere Tamburi che hanno fatto richiesta nel 2024. Infine, viene riconosciuto al gruppo Acciaieria d’Italia un indennizzo per le imprese a forte consumo di energia, in particolare per gli sconti sulle forniture energetiche e per le quote ETS (Emission Trading System; le quote di scambio di CO2).
Si verificherà poi se la Commissione europea richiamerà al rispetto delle regole sugli aiuti di Stato all’impresa. Si dice anche che il nuovo piano di decarbonizzazione è quadriennale e che è in atto una trattativa riservata con un nuovo acquirente. Gli effetti della riduzione della produzione della ex Ilva produce ricadute sugli altri stabilimenti a valle del ciclo produttivo e sull’indotto con inevitabile esubero strutturale di personale per tutti i siti.
Da gennaio 2026 le persone in cassa integrazione saranno 6 mila. Muto il governo sulle politiche attive del personale in cassa integrazione, come la legge prescrive. Comunque esiste anche la cialtronata di non mettere mano sui 5 miliardi del PNRR per il programma GOL ( (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). E mancano 40 giorni. Soldi che potevano essere usati per la conversione di tutta l’area tarantina ex Ilva.