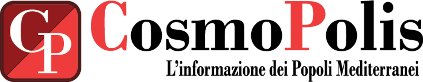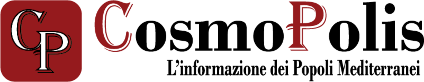di Armando De Vincentiis
Le affermazioni dei leader europei non sono semplici avvertimenti militari, ma sono messaggi culturali e psicologici che mirano a normalizzare il lutto e trasformare la more in un dovere patriottico. Ma la realtà che si cela dietro queste parole è ben diversa: a morire non sono i figli dei leader che pronunciano queste frasi, bensì giovani soldati che cadono sul campo, agonizzanti, pensando per l’ultima volta ai genitori, alla fidanzata, alla vita che non avranno più
Premessa necessaria: nessuno intende giustificare l’invasione russa dell’Ucraina, che resta una violazione del diritto internazionale e un atto di aggressione inaccettabile. Tuttavia, questo non impedisce di osservare la gestione fallimentare e pericolosa della crisi da parte dell’Europa e della NATO, sempre più impegnate a normalizzare l’idea della guerra come destino inevitabile.
Negli ultimi mesi, dichiarazioni di leader europei e dell’Alleanza Atlantica hanno colpito per la loro crudezza. Mark Rutte, nuovo segretario generale della NATO, ha affermato che dobbiamo essere pronti a vivere la guerra come i nostri nonni e bisnonni, adottando una mentalità da tempo di guerra. Il generale francese Fabien Mandon ha dichiarato davanti ai sindaci di Francia che bisogna abituarsi all’idea di perdere i propri figli in un eventuale conflitto. Più recentemente, Kaja Kallas ha ribadito che la guerra deve essere prolungata per logorare la Russia, anche a costo di ulteriori sacrifici.
Queste frasi non sono semplici avvertimenti militari. Sono messaggi culturali e psicologici che mirano a normalizzare il lutto e a trasformare la morte in un dovere patriottico. Ma la realtà che si cela dietro queste parole è ben diversa: a morire non sono i figli dei leader che pronunciano queste frasi, bensì giovani soldati che cadono sul campo, agonizzanti, pensando per l’ultima volta ai genitori, alla fidanzata, alla vita che non avranno più. È uno scenario che chi programma la guerra non ha davanti agli occhi, perché la morte viene ridotta a statistica, a numeri da giocare sul campo di battaglia.
Qui entra in gioco la dimensione psicopatologica della leadership politica: la dissociazione e la deresponsabilizzazione. Dissociazione, perché i leader separano le loro parole dalla realtà concreta che esse implicano e distaccano la percezione emotiva da ciò che propongono: parlano di sacrificio senza immaginare il volto di un giovane che muore, immagine troppo disturbante da sostenere mentre pronunciano quelle frasi. Deresponsabilizzazione, perché spostano il peso delle loro decisioni dal piano politico al piano morale, trasformando la tragedia in un destino collettivo e scaricando la responsabilità sui cittadini. Così, chi contesta la guerra viene bollato come vigliacco o traditore, mentre chi la sostiene appare come patriota.
La propaganda funziona come un’ipnosi collettiva: ripete ossessivamente slogan, infonde paura in un nemico dipinto come mostro da abbattere, trasforma la tragedia in destino e la guerra in normalità. Dissociazione e deresponsabilizzazione diventano così strumenti di governo: i leader si liberano dal peso delle conseguenze delle loro scelte, mentre i cittadini vengono indotti ad accettare la morte come inevitabile. A questo si aggiunge il meccanismo psicologico noto come illusione di verità: più un concetto viene ripetuto, più appare credibile, anche in assenza di prove. Così, la continua reiterazione di formule come “pace giusta”, “riarmo necessario”, “la Russia ci attaccherà” finisce per sedimentarsi nella coscienza collettiva, trasformando percezioni in convinzioni e convinzioni in consenso politico. La cosa triste è che funziona davvero!
Nella storia delle guerre, ogni leader ha usato la retorica del sacrificio per legittimare decisioni politiche ed economiche. Il concetto di “morire per la patria” è una costruzione del potere, utile a convincere i cittadini che la loro morte ha un senso, mentre in realtà è funzionale a interessi strategici ed economici. Oggi l’Europa sembra ripetere lo stesso copione: non propone veri piani diplomatici, ma alimenta la tensione con dichiarazioni aggressive e programmi di riarmo miliardari. La guerra diventa così non solo un rischio, ma un’occasione economica per l’industria bellica.
Le parole di Rutte, Mandon e Kallas non sono semplici analisi strategiche: sono strumenti di propaganda che cercano di abituare le società europee alla guerra, al lutto e alla tragedia. La psicologia ci insegna che dietro queste frasi c’è un processo di dissociazione e disumanizzazione: i cittadini non sono più persone con affetti e famiglie, ma numeri sacrificabili.
Ma come mai la storia non ha insegnato nulla ai nostri leader? Alcuni, come Kaja Kallas, sembrano non conoscerla nemmeno, e già questo in minima parte potrebbe giustificare le sue parole. Solo attraverso questo meccanismo di difesa si può comprendere come mai un leader arrivi a parlare di morte, lutto, perdita di familiari come se fossero una cosa utile e necessaria. Perché è di questo che parlano, ma lo fanno attraverso un linguaggio moralistico che inganna il popolo, trasformando la tragedia in virtù.
In realtà, se vedessero davvero la concretezza di ciò che dicono – un giovane che agonizza sul campo pensando per l’ultima volta ai suoi genitori o alla sua fidanzata – non pronuncerebbero quelle frasi e non si preparerebbero a una guerra che sembra voluta più da loro che dal nemico dipinto come mostro. E così continuiamo a dire che ci attaccherà, continuiamo a riarmarci, continuiamo a riempire le casse delle industrie belliche, mentre a morire saranno i giovani soldati, i figli di noi cittadini comuni.