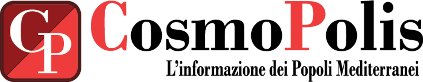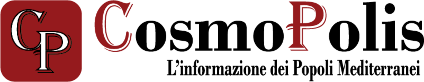“‘Date la palla a Totò che sa lui cosa deve farci’. Non era una frase: era un atto di fiducia. Consegnargli il pallone era come metterlo in banca. Con lui il gioco respirava. Non correva dietro alla partita, la guidava. Dettava il ritmo come un metronomo silenzioso, faceva muovere i compagni con un gesto, con un’idea, con uno sguardo”
Totò Lopez, l’uomo che dava un senso al tempo. Ci sono giocatori che toccano il pallone. E poi ci sono quelli che lo ascoltano. Totò Lopez lo ascoltava.
A Bari, nel 1971, un ragazzo di diciotto anni entrò in campo allo Stadio della Vittoria con il cuore che batteva più forte del pubblico. Indossava la maglia del Bari, la squadra della sua città. Non era soltanto un esordio. Era un passaggio di vita. Davanti aveva la sua gente, sugli spalti le voci che conosceva da sempre. Allenatore: Lauro Toneatto. Ruolo: rifinitore. Destino: diventare altro.
All’inizio era un ragazzo che cercava l’ultimo passaggio, l’intuizione tra le linee. Poi arrivò l’incontro che cambia le traiettorie: Tom Rosati. Rosati non vedeva solo un talento offensivo. Vedeva un direttore d’orchestra. Gli mise il pallone tra i piedi e gli disse, in sostanza: “Adesso pensa tu”. E Totò iniziò a pensare per tutti.
“Date la palla a Totò che sa lui cosa deve farci”. Non era una frase: era un atto di fiducia. Consegnargli il pallone era come metterlo in banca. Con lui il gioco respirava. Non correva dietro alla partita, la guidava. Dettava il ritmo come un metronomo silenzioso, faceva muovere i compagni con un gesto, con un’idea, con uno sguardo.
A Pescara vinse e si consacrò. Lì capì definitivamente che il suo posto era al centro del campo, nel cuore strategico del gioco. Non per spezzare, ma per costruire. Poi Roma. La chiamata di Tommaso Maestrelli. La maglia della Lazio, in uno spogliatoio che profumava ancora di scudetto, con personalità gigantesche come Giorgio Chinaglia e Pino Wilson. Non fu semplice. Le gerarchie erano solide, la diffidenza naturale. Bisognava guadagnarsi tutto.
Totò non parlava molto, giocava. E quando giochi così, prima o poi il pallone ti rende giustizia. Nel 1981/82, con il Palermo FC, tocca uno dei vertici della carriera. È leader tecnico, è guida emotiva. Vince il Guerin d’Oro come miglior interprete del suo ruolo. I rosanero sfiorano la Serie A. Lui è nel pieno della maturità: non solo bravo, ma consapevole.
E poi il ritorno a casa. Di nuovo Bari. Il presidente Vincenzo Matarrese crede in lui, Bruno Bolchi gli costruisce attorno una squadra giovane, affamata. Totò diventa la chioccia, il riferimento, la guida. In campo e nello spogliatoio. Non impone: orienta. Non comanda: ispira. È il tipo di giocatore che migliora gli altri. E questo non finisce nelle statistiche.
Chiude nel 1986 a Taranto, richiamato ancora da Rosati. Un ultimo atto di fedeltà reciproca. Un maestro e il suo allievo. Il cerchio che si chiude.
Il regista che manca
Oggi il calcio corre più veloce. Pressing, transizioni, verticalità immediate. Il tempo sembra nemico. E il ruolo del regista classico, quello che respira dentro la partita, è diventato raro, quasi fragile.
Totò Lopez giocava prima con la testa e poi con i piedi. Sapeva leggere un movimento prima che accadesse. Sapeva suggerire una posizione senza gridare. Giocava anche quando non toccava la palla, perché occupava lo spazio giusto per dare un senso a quello degli altri.
Nel nostro campionato, oggi, chi conserva questa arte è Luka Modrić. A quarant’anni continua ad anticipare, a intuire, a muoversi senza pallone per creare linee invisibili. Non domina con il fisico, ma con il tempo. Lo piega, lo rallenta, lo accelera. Come faceva Totò.
Il regista vero non è solo un ruolo, è una responsabilità. È prendersi il peso della scelta quando gli altri cercano un appoggio. È essere il punto di riferimento quando la partita si confonde. Totò Lopez, nella sua misura, non è stato soltanto un buon calciatore. È stato un uomo che dava un senso al tempo. E finché esisterà qualcuno capace di fare questo, il calcio resterà un gioco pensato, non solo giocato.