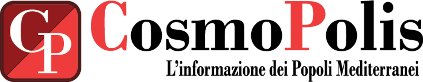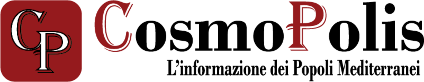Il calcio italiano è arrivato al limite. Non si tratta più di prevedere se il sistema imploderà, ma quando. Gennaio, febbraio, marzo: ogni mese porta con sé l’ennesimo caso di inadempienza, l’ennesima penalizzazione, l’ennesima società che non riesce a chiudere la stagione
Zona Cesarini per il calcio italiano: la riforma non è più rinviabile. Da settimane assistiamo alla solita polemica, stantia e improduttiva, sui risultati della Nazionale maggiore. L’eventualità, oggi concreta, che l’Italia possa mancare ancora una volta la qualificazione ai Mondiali viene agitata come clava politica interna: se gli Azzurri restano a casa, dicono i critici, a pagare dovrebbe essere il presidente della Federcalcio. Un refrain sterile, diventato quasi un esercizio di autoassoluzione collettiva: si identifica un capro espiatorio, lo si sacrifica sull’altare mediatico e si finge che tutto ciò basti a guarire un sistema malato.
Ma è davvero il presidente federale il responsabile dei mali del calcio italiano? Davvero l’avvicendamento al vertice, invocato come balsamo miracoloso, sarebbe sufficiente a risolvere problemi che affondano le radici in decenni di immobilismo, conflitti interni e interessi corporativi? La risposta è sotto gli occhi di tutti: no. E continuare a fingere il contrario significa condannare il sistema a un declino irreversibile.
L’Italia del pallone è il paradosso della sostenibilità
Nel nostro calcio la parola “sostenibilità” è diventata un sostantivo da vocabolario: esiste sulla carta, non nella realtà. Quasi tutte le componenti, chi più chi meno, chiudono i bilanci in rosso.
La Serie A continua a rivendicare di essere l’unica forza economica del sistema, quella che grazie alla legge Melandri tiene in piedi l’intero movimento: il 10% dei diritti televisivi, circa 130 milioni annui, viene redistribuito a cascata verso Serie B, Lega Pro, LND, arbitri, Federazione e rimanenti componenti .
Solo la Lega Pro incassa, tra quota Melandri e fondi Federcalcio, quasi 30 milioni di euro a stagione. Una cifra considerevole, che tuttavia, alla prova dei fatti, non basta minimamente a garantire stabilità. Il motivo è semplice: la Serie C è un campionato insostenibile nella sua attuale configurazione.
Sessanta squadre, tre gironi, proprietà spesso fragili, continui deferimenti, penalizzazioni ed esclusioni. Negli ultimi anni le cronache hanno raccontato le difficoltà di Triestina, Campobasso, Trapani, Taranto, Spal, Lucchese, Turris. L’ultimo caso, quello del Rimini già estromesso in corso d’opera, è l’ennesima conferma di un modello logoro, illogico, incapace di garantire il minimo principio dell’affidabilità economica.
La Serie C così com’è non regge più. E con essa rischia di crollare l’intera piramide.
La riforma possibile: due sole leghe professionistiche
Se c’è una parola che tutto il sistema pronuncia, salvo poi ritrarsi di fronte al momento della decisione, è riforma. Ma è l’unica strada praticabile. Accenniamo a una riforma concreta, condivisa, strutturale la quale potrebbe poggiare su alcune colonne portanti:
- Due sole leghe professionistiche
– Serie A a 18 squadre.
– Serie B allargata a 36, divisa in due gironi: B1 (continuazione dell’attuale) e B2 (nuova costituzione, con criteri di solidità economica e merito sportivo). - Ridisegno dei meccanismi di promozioni e retrocessioni, più snelli, più meritocratici.
- Sotto il professionismo, un grande campionato interregionale gestito da una LND rinnovata, con spazi di semiprofessionismo e forme contrattuali alleggerite sul piano contributivo.
- Redistribuzione mirata dei fondi Melandri
Una parte significativa dei quasi 30 milioni destinati oggi alla Serie C potrebbe andare alla nuova B2 (20–25 milioni), con il resto alla nuova LND. Un investimento strategico per sostenere un sistema più piccolo, più selettivo e finalmente stabile.
Non è una rivoluzione romantica: è una rivoluzione necessaria. Continuare a sostenere 60 club professionistici significa alimentare una struttura già oggi prossima al collasso.
Il tempo è scaduto: siamo in “zona Cesarini”
Il calcio italiano è arrivato al limite. Non si tratta più di prevedere se il sistema imploderà, ma quando. Gennaio, febbraio, marzo: ogni mese porta con sé l’ennesimo caso di inadempienza, l’ennesima penalizzazione, l’ennesima società che non riesce a chiudere la stagione.
E allora, usando un termine che ben conosciamo, siamo ufficialmente arrivati in zona Cesarini. Non c’è più margine per rinvii, tatticismi, veti incrociati. Entro marzo il Consiglio Federale deve mettere la riforma al centro dell’agenda e approvarla. È l’unico modo per salvare un movimento che ha ancora un enorme capitale sociale, culturale ed economico, ma che rischia di polverizzarsi se non viene riportato alla ragione.
La Nazionale può essere il termometro, ma non è la causa del male. Il problema è il corpo del calcio italiano, che oggi è febbricitante. E continuare a discutere solo di chi debba “pagare” significa ignorare la malattia e perdere tempo prezioso.
È l’ora, finalmente, della responsabilità. È l’ora della riforma. Non per la Federazione, non per la politica sportiva, ma per il futuro del nostro calcio.