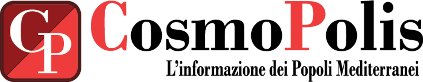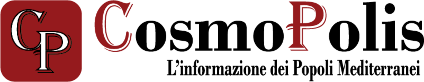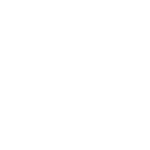di Rosa Elenia Stravato
Dai prestiti dall’inglese alle invenzioni degli scrittori, le parole nuove fotografano il nostro presente e alimentano il dibattito tra puristi e innovatori
Cosa rende viva una lingua? Il fatto che venga parlata o che acquisisca nuovi termini, aggiornandosi al tempo mutevole che viviamo? Si chiamano “neologismi” ossia “parole di nuova formazione” possono e nascere per diversi motivi: in primis per descrivere realtà nuove (spesso legate a scoperte scientifiche, tecnologie o fenomeni sociali); per adattare prestiti da altre lingue e per innovazioni linguistiche create da scrittori, giornalisti o parlanti comuni. I neologismi possono essere temporanei (destinati a scomparire) oppure stabilizzarsi e diventare parte del vocabolario comune. Insomma: i neologismi rendono nuova, fresca e scintillante la nostra lingua. Non stiamo parlando di qualcosa di nuovo, eh no! Gabriele D’Annunzio ebbe un ruolo in primo piano nella creazione e diffusione di neologismi nella lingua italiana. La sua ricerca espressiva e la sua sensibilità estetica lo portarono a inventare o reinventare parole, spesso per forbire il lessico con sfumature poetiche e suggestive. È lui l’inventore di parole quali: “tramezzino”; “velivolo”; “ormeggiare”. Sono oltre mille i neologismi entrati nello Zingarelli 2026, e non sorprende che molti di questi arrivino dall’inglese. La lingua, infatti, vive di prestiti e contaminazioni, e oggi l’inglese è la fonte più fertile: dal mondo della tecnologia ai social, dalla scienza alla cultura pop, i nuovi termini entrano nel nostro vocabolario quasi senza che ce ne accorgiamo. E così tra anglicismi e neologismi, la nostra bella lingua strizza gli occhietti al buon Alighieri e si imbatte in parole come: “breccare” che proviene dal mondo del tennis e indica la vittoria sull’avversario, oppure “scavetto” indicante il calcistico tiro a cucchiaio. C’è spesso tensione fra l’innovatore ed il purista -conservatore: il purismo difende forme ritenute “classiche”, chiede che la lingua resti comprensibile, uniforme; gli innovatori spingono verso l’esplorazione. Dal 2026, tuttavia, i puristi della nostra lingua dovranno accettare termini come “bromance” ossia il legame tra due uomini di forte amicizia; “aporofobia” ovvero la paura della povertà; “retromania”cioè l’atteggiamento di nostalgia per il passato. Il fatto che un dizionario come lo Zingarelli registri questi cambiamenti non significa soltanto che la lingua si arricchisce: significa soprattutto che la lingua si muove, respira, fotografa la società in tempo reale. Ogni parola nuova racconta qualcosa del presente: le nostre paure, le nostre passioni, i nostri strumenti quotidiani. Ci sarà spazio, anche, per “amichettismo” indicante la tendenza a favorire gli amici senza meriti specifici; “gaslighting” vale a dire la tendenza a manipolare psicologicamente una persona al fine di portarla a dubitare delle proprie percezioni.
Pirandello sosteneva che: “abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai!”. Il rischio che l’abbondanza di parole nuove, specialmente se importate da altre lingue, produca incomprensione, elitismo, frammentazione linguistica è una delle paure che anima i dibattiti che dalle aule universitarie scendono anche negli anfratti. È importante, quindi, che i neologismi mantengano qualche ancoraggio cioè che siano motivati dal bisogno, coerenti con fonetica, morfologia ed uso; possano essere compresi, trasmessi, condivisi in maniera chiara e coerente. I neologismi, quindi, si attestano come uno dei motori principali dell’evoluzione linguistica e letteraria. Autori come Ungaretti e Calvino non solo hanno contribuito con esempi concreti di nuovi modi di espressione, ma hanno anche stimolato la riflessione sull’uso della parola, sullo stile, sulla responsabilità dello scrittore verso la lingua. Nel mondo contemporaneo, la velocità del cambiamento culturale, l’innovazione tecnologica, l’influsso di media globali e digitali rendono ancora più urgente e visibile il fenomeno: la lingua italiana -come tutte le lingue vive- ha la necessità naturale non solo di accogliere vocaboli nuovi, ma di saperli selezionare, usare con consapevolezza, perché siano strumenti utili alla comunicazione e alla creazione artistica, non semplici mode superficiali.