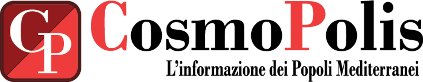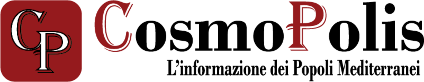Il marchio Peroni punta forte su quella che un tempo era la birra della città dei due mari, stravolgendone però l’essenza. Il brand Puglia fagocita ancora una volta quello jonico,
A primo acchito, credevo d’aver sentito male. Si perché, sarà pur vero che per noi del secolo scorso, Milàn resta sempre un gran Milàn, ma uno conto è la stazione centrale del capoluogo lùmbard, terronamente tappezzata col logo “Raffo”, e un altro è l’elitario intervallo su Canale 5, di un quarto finale di Champions League. E che quarto di finale.
Un italiano medio (e quindi non sua Eccellenza Carlo Ancelotti), abituato alle sonnolenze ritmiche del calcio tricolore mal si presta ad una gestione serena di un Real Madrid – City, come quello andato in scena ieri sera, e allora quel quarto d’ora di pausa, a me serviva nella medesima misura in cui ne necessitavano a Ruben Dias e Camavinga. La differenza stava nel (mio) programma: birra, pisciata trattenuta per non perdersi nemmeno un pensiero dei ventidue in campo, sguardo distratto al figlio estremamente molesto, con la speranza che mia moglie potesse angelicamente accompagnarlo a letto (bello di papà, ndr) e ghiaccio mentale che anestetizza sino al ritorno in campo.
Questo sarebbe stato, se non mi fossi sciaguratamente imbattuto in una tv ultrasottile, quella del mio soggiorno, che trasmetteva, probabilmente da Marte, l’annientamento totale di una dottrina sulla quale poggia la comunità nella quale vivo e sono cresciuto.
Il primo schiaffone me lo tira il Castello Aragonese, il secondo con la stessa celerità del Trinità di Terence Hill, la spiaggia di Polignano; la pistola puntata sotto il mento invece, me la piazza il sentire che la “Birra Raffo, arriva dalle terre più pugliesi della Puglia”. Respiro profondo.
Mi aggrappo alla poltrona e asciugo il sudore tra le righe della fronte, perché per trentacinque anni a mo’ di credere, obbedire e combattere, ho imparato che la Birra Raffo, pure ce no je chiù bone come apprime, e ce non ge a fanne chiù a Tarde (anche se non conserva il medesimo sapore di un tempo, e pur non essendo più prodotta nel capoluogo jonico, tradotto per quelli che leggono da fuori Taranto), sia la bevanda identitaria del tarantino, di un popolo svezzato a Luppolo, Cozze e niente altro.
Me l’ha detto mio nonno (non mio padre, che l’ha sempre cagata altamente), l’ho letto sui cartelloni pubblicitari disseminati per le vie della mia città, rigorosamente a tinte rossoblu, lo hanno cantato per anni gli artisti su notissimo palco in piena estate, me lo raccontato coi piedi Ciro Muro e Christian Riganò con le esultanze sotto quella Curva, a cui “A Raffozza Croccande” sta esattamente come la Cervogia ad Asterix ed Obelix.
Al bando campanile e goliardia, la sensazione di stupore, non ha avuto motivo di durare più di una manciata di secondi, con la riflessione che ha però restituito come unico totale, lo scollamento definitivo e senza via di ritorno tra Taranto e la sua birra.
Il passaggio sotto l’egida Peroni, ad inizio anni novanta ed ancor più l’ascendenza nipponica con il trasferimento del marchio al gruppo Asahi, sono il fisiologico passaggio ad un mercato globale che non gioca con le stesse carte con le quali si mettono al tavolo i sentimenti.
La scelta, obbligata non prevedeva il mantenimento di un’anima, non contemplava la possibilità di conservare quell’aura di tradizione, di effimera purezza e legame che nonostante tutto, teneva ancora attaccate quella bottiglia in vetro marrone ed il Ponte Girevole.
Reinventarsi o morire, o meglio reinventarsi per non morire. Allargare il bacino d’utenza, diventare mainstream, alla portata di tutti e di tutta Italia, da Santa Maria di Leuca a Bergamo, uscendo dalla logica chiusa della territorialità, dell’appartenenza, quell’orgoglio sommesso che ci ha portato più volte a confessare “Lo sai che all’Auchan di Roma Collatina tengnono la Raffo?”, manco fosse un segreto di Fatima, per entrare nell’ottica di “Due Raffo? Sette euro, grazie”, magari all’ombra del Colosseo.
Glielo ha chiesto il mercato, che in cambio della promozione, in cambio del red carpet, ha voluto un trucco nuovo, un taglio di capelli diverso e cosa ancora più grave un corso di dizione accelerato affinché si cancellasse del tutto il timbro tarantino, per far spazio al più spendibile accento genericamente pugliese. Anzi puglieeeeese.
McCann, piuttosto che Think Cattleya, e forse ancor di più le copertine di Vanity Fair e Rolling Stones, e le reclame di Gambero Rosso, sono il prezzo da pagare per l’addio e fanno capire anche agli ostinati, che il tempo del boccale marchiato, a casa della nonna e dell’etichetta tutta rossa, sono ormai solo storia.
Termina così, con la consapevolezza di aver chiuso una relazione nella quale Taranto ha certamente dato più di quanto fosse giusto dovesse ricevere. Se Raffo oggi, può giocarsi le su chance, lo deve solo ed esclusivamente a chi per 100 anni l’ha scelta, senza che sul territorio sia rimasto segno tangibile della partnership con l’azienda, senza che Raffo abbia creato qualcosa per Taranto. Da altre parti del mondo, pare lo chiamino sfruttamento.
Fuori la lavagnetta luminosa, cambio: esce Taranto, appaluso, standing ovation, dentro Puglia. Bello, per un bergamasco che sogna il mare, ma per noi, non fa lo stesso.
Adieu, Raffò!