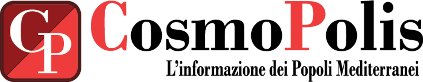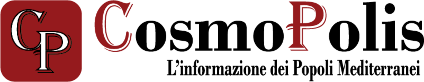di Rosa Elenia Stravato
Lo studioso Fabio Frisino ci conduce nelle viscere della nostra identità culturale, ci sveste degli orpelli e ci ricorda quanto le nostre tradizioni parlino un linguaggio – forse- molto più universale di quanto crediamo
Chi è e cosa fa un antropologo? Che cos’è l’antropologia? Sono interrogativi che, spesso, non ci poniamo ma che – poi- piombano nelle nostre giornate e ci colgono di sorpresa. L’antropologo è, prima ancora che uno specialista, una figura liminare: abita le soglie, si muove negli interstizi tra culture, linguaggi e forme di vita. Studioso dell’umano nella sua interezza, egli non si limita a osservare dall’esterno, ma accetta di esporsi all’incontro, al confronto, talvolta allo spaesamento. L’antropologia, infatti, non è soltanto una disciplina accademica: è un esercizio dello sguardo e dell’ascolto, una pratica di decentramento che obbliga a mettere in discussione le proprie categorie interpretative. Ciò che rende singolare l’antropologo è il metodo, fondato sull’esperienza diretta e sulla partecipazione. Attraverso il lavoro sul campo, egli condivide tempi, spazi e gesti delle comunità che studia, riconoscendo valore conoscitivo alle pratiche quotidiane, ai rituali, alle narrazioni orali. In questa prossimità, mai ingenua né neutrale, l’antropologo apprende che ogni cultura è un sistema complesso di significati, coerente al proprio interno e irriducibile a spiegazioni semplicistiche.
Lo studioso di antropologia, in questo senso, è un interprete del simbolico. Il suo compito non è giudicare, né tradurre l’altro nei termini del già noto, ma restituire la pluralità delle forme umane, mostrando come credenze, istituzioni e comportamenti rispondano a logiche storiche e sociali specifiche. La sua scrittura, come il suo pensiero, si colloca tra scienza e racconto, tra analisi rigorosa e sensibilità etnografica. In un tempo segnato da conflitti identitari e semplificazioni culturali, l’antropologo incarna una postura etica oltre che intellettuale: quella di chi riconosce la differenza come risorsa conoscitiva e la complessità come dato imprescindibile dell’esperienza umana. La sua singolarità risiede proprio qui, nell’essere custode di uno sguardo capace di tenere insieme distanza critica e profonda empatia, rigore scientifico e attenzione umana. In questo ampio spazio si colloca il testo di Fabio Frisino “Corpi inquieti. Le narrazioni mediche e culturali del tarantismo”.
Un testo ambizioso, laddove l’ambizione è il mezzo attraverso il quale far emergere tutte le sfaccettature di un fenomeno che – in fin dei conti- ci appartiene nel profondo. Il volume, edito da Editrice Bibliografica, si propone di ricostruire con rigore e originalità le narrazioni mediche, scientifiche e culturali del tarantismo dalla modernità alla contemporaneità. Attraverso un percorso inedito, l’opera valorizza la dimensione scientifica di un fenomeno dai tratti perturbanti e inattesi, restituendone la complessità antropologica e offrendo una lettura capace di tenere insieme corpo, sapere e cultura. Il testo ci restituisce l’immagine di corpi attraversati dall’inquietudine e dal tremore che si lasciano andare alla danza come a un gesto estremo di salvezza, nella convinzione che il movimento possa espellere il veleno invisibile della tarantola pugliese. È questo l’orizzonte simbolico del tarantismo in età moderna, una delle più celebri e controverse sindromi culturali della storia europea, che l’antropologia ha riconosciuto come dispositivo complesso di risposta al dolore, al disagio psichico e alla marginalità sociale. Lungi dall’essere riducibile a una mera patologia, il tarantismo si presenta come linguaggio del corpo e rito collettivo, inscrivendosi in un contesto storico segnato dal pluralismo terapeutico, in cui la medicina dotta conviveva con pratiche religiose, credenze popolari e saperi empirici.
Nel Seicento, questo intricato coacervo di interpretazioni e pratiche venne progressivamente ricondotto entro i confini del dibattito medico e naturalistico. Fisici, filosofi della natura e medici tentarono di classificare il fenomeno, di sottrarlo all’ambiguità del rito per tradurlo in termini razionali e nosografici. Tuttavia, tale sistematizzazione non riuscì a sciogliere il nodo della sofferenza che il tarantismo incarnava, né a esaurirne la forza simbolica, che continuava a eccedere ogni spiegazione univoca. Tra Otto e Novecento, esso fece il suo ingresso nei territori della psichiatria nascente, trovando spazio nelle cartelle cliniche degli ospedali psichiatrici della Belle Époque e divenendo oggetto di osservazioni sempre più articolate, al crocevia tra medicina, psicologia e antropologia. Le indagini etnografiche ne colsero la dimensione rituale e culturale, riconoscendo nel tarantismo una forma di espressione simbolica del disagio, radicata in un preciso contesto storico e territoriale. Una volta dissoltosi come pratica terapeutica viva, il tarantismo conobbe una metamorfosi ulteriore. Liberato dal peso della sofferenza individuale e dalla stigmatizzazione sociale, esso si è progressivamente trasfigurato in spettacolo, linguaggio performativo, patrimonio culturale rielaborato e messo in scena. La danza, un tempo strumento di cura e di sopravvivenza, si è fatta memoria estetizzata, segno identitario, racconto plurale. Pelle comune sotto la quale riconoscersi parte di un sistema condiviso.