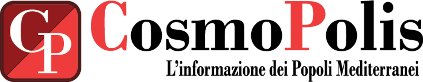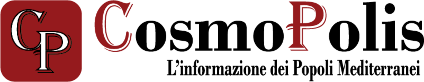di Rosa Elenia Stravato
Dalla purezza contadina del Salento al fumo siderurgico di Taranto, Pasolini trasformò il Mezzogiorno in un poema di luce e dolore, trovando nel Sud d’Italia l’eco universale della sua inquietudine
Ci sono figure che attraversano la storia non solo per ciò che hanno detto o scritto, ma per il modo in cui hanno saputo incarnare il disagio e la bellezza del proprio tempo. Pier Paolo Pasolini (1922–1975) appartiene a questa categoria di spiriti inquieti, profetici, irriducibili. Poeta, regista, romanziere, drammaturgo e polemista, Pasolini è stato – e continua a essere – un punto di riferimento imprescindibile nella cultura italiana e internazionale. La sua opera, poliedrica e scomoda, ha saputo denunciare le ipocrisie della modernità, restituendo voce agli ultimi, agli esclusi, a quelle “vite umili” che egli amava osservare e raccontare senza filtri. La poesia di Le ceneri di Gramsci, la potenza cinematografica di Accattone, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo, la crudele purezza di Salò o le 120 giornate di Sodoma: ogni gesto artistico di Pasolini è un atto politico, una dichiarazione d’amore e di dolore verso l’Italia e un’umanità in trasformazione. Allo stesso modo, il teatro pasoliniano – da Calderón a Pilade – è uno spazio di verità, un altare laico dove il linguaggio si fa corpo e il corpo diventa linguaggio. C’è sempre un Pasolini da scoprire ed è questa l’occasione per raccontare la sua devozione verso il Sud Italia; nel suo percorso intellettuale e umano, Pasolini ha riservato al Sud uno sguardo privilegiato. La Puglia, in particolare, è stata per lui punto di scoperta e riflessione, terra dove l’arcaico e il moderno convivono in una tensione poetica irriducibile. Come egli stesso affermò in uno dei suoi scritti, «il Sud è l’innocenza che resiste, ma anche la vittima che si consuma». Nel 1960 collaborò con la regista pugliese Cecilia Mangini per il documentario Stendalì – Suonano ancora, dedicato ai lamenti funebri contadini del Salento. Pasolini ne curò il testo, un canto dolente e sacrale che trasforma la morte in rito collettivo, in poesia visiva. In quegli stessi anni, per la Rai, lavorò a una serie di inchieste sul Mezzogiorno, cercando di restituire dignità a un Sud troppo spesso dimenticato: la sua voce, chiara e ferma, raccontava un’Italia che si stava perdendo nell’illusione del progresso.
Il 21 ottobre 1975, pochi giorni prima della sua tragica morte, Pasolini parlò agli studenti di un liceo di Lecce. Nel pomeriggio si recò a Calimera, piccolo centro del Salento greco, dove incontrò volti, gesti, silenzi che lo colpirono profondamente. In quei giorni, la sua riflessione si fece ancora più accorata: avvertiva il dissolversi di una civiltà contadina che per lui rappresentava l’ultima traccia di autenticità nel mondo moderno. La Puglia fu anche teatro di amicizie profonde. Con il poeta Vittorio Bodini, salentino, Pasolini intrattenne un dialogo fecondo. Nel 1968 gli chiese un sostegno per Teorema, candidato al Premio Strega: segno di una stima reciproca che travalicava le frontiere letterarie. E poi Taranto, “la città dei due mari”, luogo che Pasolini descrisse come “una meraviglia che non sa di esserlo”. La sua fascinazione per Taranto era legata a un senso di mistero, a quella doppia natura sospesa tra sacro e industriale, tra Mediterraneo e fumo d’acciaio. Pasolini intuì, prima di molti, il destino contraddittorio di quella città, simbolo di un Sud che paga il prezzo della modernità. Taranto occupa una posizione singolare, sospesa tra fascinazione e inquietudine; la “città dei due mari” rappresentava per il regista non soltanto una geografia reale, ma un simbolo potente: un crocevia di civiltà, una soglia tra passato e futuro, tra sacro e profano. Egli giunse a Taranto negli anni Sessanta, nel corso dei suoi viaggi nel Mezzogiorno per inchieste e lavori cinematografici. La città, allora in piena trasformazione industriale, lo colpì per la sua bellezza antica e il suo destino contraddittorio. La definì una “meraviglia che non sa di esserlo”, cogliendo in poche parole la sua natura ferita: da un lato il mare, la luce greca, la stratificazione millenaria della Magna Grecia; dall’altro, l’avanzare del cemento, il nuovo polo siderurgico, l’inizio di una modernità devastante. Taranto gli apparve il riflesso di quella “mutazione antropologica” che egli denunciava in tutta Italia: la perdita dell’identità contadina e popolare, sostituita da un modello industriale e consumistico che uniformava ogni diversità. Tuttavia, la città lo affascinava proprio per il suo dualismo, per la capacità di conservare – sotto le scorie del progresso – un’anima arcaica, profondamente mediterranea. Più volte, nelle sue interviste, ha parlato di Taranto come di un luogo “metafisico”, dove la bellezza naturale si intreccia alla violenza del tempo moderno. Il Mar Grande e il Mar Piccolo diventavano, nella sua visione poetica, due specchi dell’animo umano: uno aperto al mondo, l’altro chiuso nella memoria.
“In questi luoghi – scrisse – la povertà ha ancora il volto dell’innocenza, e la luce del Sud non ha ceduto del tutto al bagliore dei neon”. Taranto, dunque, non fu per Pasolini una semplice tappa, ma un simbolo vivente di quella tensione tra purezza e corruzione che percorre tutta la sua opera. La città incarnava la tragedia e la bellezza del progresso, la perdita e la memoria, il corpo e l’anima di un’Italia in metamorfosi. Questo doppio sguardo – tra nostalgia e consapevolezza storica – fa di Taranto una sorta di emblema pasoliniano del Sud. Non un semplice spazio geografico, ma un corpo simbolico, dove l’Italia antica e quella nuova si scontrano dolorosamente. La potenza dello sguardo pasoliniano sta nell’aver reso Taranto con una luce diversa come una città-simbolo della sua visione del mondo: un luogo di ferite aperte ma anche di resistenza poetica; un altare laico del Mediterraneo, dove il poeta ha saputo intravedere ciò che altri non vedevano: la sacralità nascosta nel quotidiano, la bellezza perduta nella modernità. Oggi, a cinquant’anni dalla sua morte, Pasolini continua a interrogarci. La sua eredità non è soltanto letteraria o cinematografica, ma etica. Egli ci ha insegnato a guardare il mondo senza compiacimento, a “dire la verità anche quando fa male”, come amava ripetere. La sua voce risuona ancora, nel frastuono contemporaneo, come un richiamo alla responsabilità intellettuale, alla pietà, alla bellezza. Pier Paolo Pasolini non appartiene al passato. È il nostro specchio più lucido e crudele, la coscienza di un’Italia che non smette di cercare se stessa tra le rovine e la speranza.