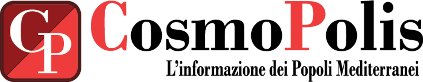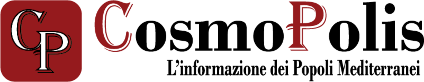di Armando De Vincentiis
L’operatore tecnico necroforo è uno di quei lavori che la società preferisce non nominare, come se bastasse ignorarlo per allontanare l’idea della fine. Eppure, proprio lì delle camere ardenti, nel gesto preciso che ricompone un corpo, nella cura che precede ogni addio) si nasconde una forma rara di competenza e di umanità
Ci sono mestieri che vivono ai margini del visibile, professioni che non cercano luce ma la custodiscono. L’operatore tecnico necroforo è uno di quei lavori che la società preferisce non nominare, come se bastasse ignorarlo per allontanare l’idea della fine. Eppure, proprio lì (nel silenzio delle camere ardenti, nel gesto preciso che ricompone un corpo, nella cura che precede ogni addio) si nasconde una forma rara di competenza e di umanità.
È un mestiere che abita il confine tra tecnica e rito, tra materia e memoria, tra ciò che resta e ciò che scompare. Un mestiere che non racconta se stesso, ma che racconta noi: il nostro modo di affrontare la perdita, di costruire memoria, di dare forma al lutto.
Ed è proprio per questo che, in qualità di psicologo che spesso lavora con l’insolito, il liminale, il mistero che attraversa le nostre vite senza mai dichiararsi, trovo non solo interessante ma anche doveroso aprire uno spazio di ascolto a chi questo confine lo abita ogni giorno. Perché ci sono professioni che, più di altre, ci costringono a guardare ciò che normalmente evitiamo, e proprio per questo diventano preziose.
Chiediamo quindi a Michela Piccione, che questo lavoro lo svolge con rispetto e consapevolezza, di aiutarci a comprendere ciò che il suo mestiere vede e custodisce.
Come cambia il rapporto con il corpo umano quando lo si incontra nel suo momento di massima vulnerabilità?
“Cambia tutto. Il corpo smette di essere qualcosa da interpretare o giudicare e diventa qualcosa da ascoltare. Non parla più, eppure racconta comunque una storia, una vita, le relazioni che ha attraversato. Nel suo momento di massima vulnerabilità non è fragile: è affidato, e questo porta con sé una responsabilità enorme. Si impara a muoversi con delicatezza, a toccare con misura, a non invadere. Quel corpo non è “solo” un corpo: è il luogo ultimo in cui qualcuno è stato. Quando lo si veste e lo si sistema, cambia. Cambia la postura, cambia la presenza, a volte persino l’espressione. È un momento che colpisce sempre, perché restituisce quiete, come se qualcosa trovasse finalmente il suo posto. Gli antichi dicevano che, se si parla a chi non c’è più mentre lo si veste, si lascia vestire. Posso dire che è vero. Non in senso magico, ma perché il corpo risponde alla cura, al tono, all’intenzione. È un dialogo silenzioso che insegna rispetto e attenzione, e rende impossibile trattare quel momento come un semplice gesto tecnico.”
Che cosa può insegnare questo mestiere sulla vita, più ancora che sulla morte?
“Insegna che la vita non è fatta solo di durata, ma di presenza. La morte rende evidente ciò che nella vita spesso rimandiamo: l’importanza dei gesti semplici, delle parole dette o non dette, della cura. Questo lavoro mostra quanto contino le relazioni, quanto contano gli abbracci non dati, le parole non dette. La morte, paradossalmente, chiarisce ciò che nella vita è essenziale.”
Lavorando con la morte, cambia il modo di percepire il tempo dei vivi?
“Sì, cambia davvero. Il tempo smette di essere qualcosa di astratto e diventa concreto, qualcosa da vivere davvero, momento per momento. Non è più qualcosa da “riempire” o da sprecare, ma diventa cura, attenzione e presenza. Si diventa più consapevoli che il tempo non aspetta nessuno e che rimandare può significare perdere cose che invece avremmo potuto vivere, dire, sentire. Ti insegna a non dare nulla per scontato e a custodire ogni attimo con più cura.”
Qual è la cosa che questo lavoro le ha insegnato sulla vita che nessun altro mestiere avrebbe potuto insegnare?
“Questo lavoro mi ha insegnato che sono i piccoli gesti a fare la differenza e che il tempo non andrebbe mai lasciato, come già accennato, tutto al rimandare. Stare nel tempo, viverlo davvero finché c’è, è forse una delle cose più difficili e più importanti. Mi ha insegnato che ogni persona merita rispetto fino all’ultimo gesto e che il modo in cui accompagniamo una fine racconta molto di come abbiamo attraversato la vita, dall’inizio a tutto ciò che sta nel mezzo. È una lezione che non si studia e non si spiega: si impara solo restando lì, giorno dopo giorno. Ricordo un uomo che, il giorno della morte della moglie, con cui aveva condiviso sessant’anni di vita, arrivò con una rosa da poggiare ai piedi della sua amata. Non disse molto. In quel gesto semplice ho sentito passare l’amore: quello vero, fatto di presenza, silenzio e cura. Ed è lì che ho capito quanto l’amore, anche alla fine, possa essere profondamente bello.”
Quanto resta di mistero, anche per chi lavora ogni giorno con ciò che la società chiama “fine”?
“Resta sempre un mistero. Anche facendo questo lavoro ogni giorno, la morte non diventa mai qualcosa di normale. Puoi conoscere i gesti, i tempi, il corpo, ma non ti abitui davvero a quel momento in cui una vita non c’è più.
Il mistero è in quello che senti quando sei lì, in silenzio, davanti a qualcuno che fino a poco prima aveva una storia, degli affetti, un nome detto da qualcuno con amore. È il rispetto che nasce spontaneo, il rallentare dei movimenti, il parlare piano, anche se sai che nessuno risponderà.
Quel mistero serve. Ti impedisce di diventare frettolosa, distratta, meccanica. Ti ricorda che non stai facendo “un lavoro qualunque”, ma stai accompagnando un passaggio. E anche nella fine, c’è qualcosa che non ci appartiene, che chiede solo di essere trattato con cura.”
Il racconto di Michela ci ricorda che la morte non è un varco metafisico, ma un fatto umano: un evento biologico che però produce effetti profondamente sociali, emotivi e culturali. Il suo lavoro mostra quanto sia importante il modo in cui accompagniamo questo passaggio, non per dare un senso alla fine, ma per dare forma alla responsabilità dei vivi. In questo, più che altrove, si vede come la cura e il rispetto non siano concetti astratti, ma pratiche concrete che definiscono una comunità.