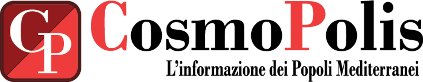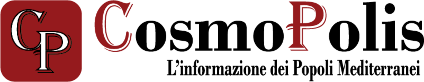di Rosa Elenia Stravato
L’interessante studio del professor De Giorgi porta l’ex colonia spartana ad appropriarsi di un’ennesimo tesoro culturale
Quando si racconta la Puglia la si connota, tra le tante cose, come la terra della “taranta”.Eppure, dietro questo cliché culturale si celano studi, voci di corridoio e tantissimi punti esclamativi. Di solito, infatti, tale fenomeno viene attribuito alla cultura salentina, eppure, recenti studi raccontano qualcosa di diverso. Ma per prima cosa, capiamoci: che cos’è il trantismo? Il tarantismo è tradizionalmente inteso come un fenomeno di tipo rituale-popolare, che si sviluppò nelle regioni meridionali d’Italia — in particolare nel Salento — a partire dal Medioevo. Secondo la credenza, una persona (detta “tarantata” o “tarantato”) — spesso una donna, ma non esclusivamente tali — sarebbe stata morsa da un ragno, la cosiddetta “taranta” (la tarantola), e avrebbe contratto una strana malattia: crisi convulsive, alterazione dello stato di coscienza, turbe emotive, sintomi che in passato venivano paragonati ad isteria o epilessia. Per liberarsi da questi effetti ritenuti velenosi, l’unica “cura” era la musica e la danza: suonatori — tamburelli, violini, organetti, armonica, e altri strumenti — accompagnavano lo “tarantato” in lunghe sessioni di danza (una forma di tarantella o di pizzica), spesso per molte ore, fino allo sfinimento. Il rito — oltre che terapeutico — aveva anche una forte valenza simbolica e sociale: la danza e la musica permettevano alla persona di “espellere” il male, di ritornare in comunità, di esorcizzare un potenziale “male” che poteva essere psichico e geografico (la credenza legata alla tarantola). Con il tempo, la componente religiosa si intrecciò a tradizioni popolari, tanto che il fenomeno venne associato — in certe comunità — alla festa di San Paolo, celebrata il 29 giugno, considerato protettore da morsi di ragno o velenosi. Negli anni Cinquanta del Novecento il tarantismo attirò l’attenzione accademica grazie a una importante “spedizione etnografica” guidata dallo studioso Ernesto De Martino, accompagnato tra gli altri dall’etnomusicologo Diego Carpitella. Carpitella — spesso con la collaborazione del folklorista statunitense Alan Lomax — raccolse canti, balli, testimonianze, registrando “sul campo” la musica della tarantella/pizzica e documentando le pratiche terapeutiche: le cosiddette “tarantate” dovevano ballare al ritmo incalzante della musica finché la crisi non si dissolvesse. Da queste ricerche derivarono registrazioni, fotografie, filmati e documentazioni sonore e visive — tra le prime di etnomusicologia visiva in Italia. Nella loro analisi, gli studiosi sottolineavano che spesso i tarantati non erano stati realmente morso da ragni, ma presentavano disturbi psicologici o sociali: quindi il tarantismo andava interpretato non come una malattia fisica, ma come un fenomeno psico-sociale e rituale, una sorta di “espediente culturale” per dare forma alla sofferenza e alla alienazione delle classi contadine. In questo quadro, la musica — e in particolare la danza suonata da musicisti esperti — assumeva un ruolo terapeutico ed esorcizzante, una cura comunitaria che permetteva di “rilassare” la mente, liberare la tensione e ristabilire un equilibrio. Secondo la tesi sostenuta dall’etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi (che ha approfondito il tema nel suo libro Tarantismo e rinascita), il tarantismo non sarebbe un fenomeno medievale o moderno, ma affonderebbe le sue radici in epoche ben più antiche — addirittura fino al VIII secolo a.C., nella antica città di Taranto, fondata dagli Spartani come “Taras”. De Giorgi propone una rilettura del tarantismo come rito dionisiaco e terapeutico, un “rito di rinascita” in cui crisi, danza, musica e mimica si combinano per produrre una trasformazione simbolica. In questo schema, la danza e la musica assumono un valore universale, atemporale: non più come superstizione popolare recente, ma come pratica arcaica di guarigione collettiva, che trova radici nella civiltà greco-spartana — o, come suggerisce De Giorgi, in una tradizione mediterranea ancora più antica — in cui mito, rito e musica si intrecciano. Secondo De Giorgi, dunque, il nome stesso “tarantismo” rimanda a “Taras” (Taranto) e non è solo un accidentale riferimento geografico risalente al Medioevo, ma allude a una tradizione originaria. Si precisa, tuttavia, che le fonti classiche, i testi antichi, l’archeologia mediterranea non restituiscono tracce del rito come tale, né riferimenti espliciti a danze curative legate a “tarante” o “tarantola” con funzione esorcistica. Per questo motivo la tesi di De Giorgi va considerata come una ipotesi speculativa importante, di tipo teorico-interpretativo: in prima istanza, restituisce al tarantismo una dimensione archetipica e pan-mediterranea, collegandolo a una tradizione antica di musica, danza e rito — rendendo la “pizzica/tarantella” non un residuo folklorico, ma la continuazione di un linguaggio primordiale di cura e liberazione. In più, consente di interpretare il tarantismo non come superstizione superstita o deviazione psichiatrica, ma come forma rituale di guarigione collettiva e di integrazione sociale: un rito liminale, di crisi e rinascita, in cui la comunità entra in gioco con strumenti di musica, danza, condivisione emotiva. Chiaro che, valorizza la radice mediterranea di molte nostre tradizioni popolari, riportando l’attenzione su antiche connessioni culturali, sul valore simbolico della musica e della danza come mezzo di espressione, liberazione, cura. Dunque, l’ipotesi che il tarantismo sia nato a Taranto già nel 750 a.C. — come propugnato da Pierpaolo De Giorgi — è di certo suggestiva e romantica poiché ci offre una chiave di lettura che collega mito, musica e riti curativi, suggerendo che la pizzica/tarantella non sia solo un’eredità folkloristica, ma la sopravvivenza di un arcaico linguaggio rituale mediterraneo.