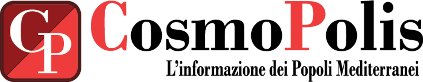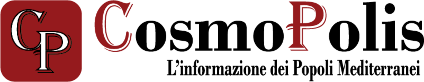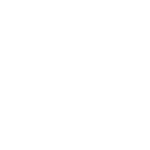In una città che decresce, che perde abitanti, nella quale non si ha più notizia del nuovo PUG, si continua a dilapidare superficie urbana. Perchè? Francesco Rosi, con il suo film di denuncia datato 1963, offrì una possibile risposta
A Taranto il consumo di suolo è pari al 21,6% dell’intera superficie urbana. Tre volte superiore alla media italiana. Cinque volte di più del dato europeo. L’aspetto è oltremodo interessante. Per una serie di considerazioni. Primo: la popolazione censita diminuisce ogni anno nell’ordine di 1500 unità. Secondo: del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), affidato al professor Karrer, si sono perse ormai le tracce. Terzo: più di un terzo delle case cittadine risulta essere sfitte (un ossimoro considerata la perdurante crisi abitativa che ci trasciniamo dietro). Quarto: l’opera di recupero – e valorizzazione – degli immobili esistenti, a cominciare da quel museo a cielo aperto rappresentato dalla Città Vecchia, è ferma. Unico caso in Italia, per quel che concerne la parte storica delle città capoluogo di provincia. Sommate tutte queste voci, la domanda direbbe qualcuno sorge spontanea. Perché, allora, consumare tanto suolo pubblico? Che necessità c’è? Perché allungare ulteriormente una città già lunga di sua? Una lingua ferita di territorio.
Francesco Rosi, con il suo film “Le mani sulla città”, pellicola di denuncia civile datato 1963, avrebbe lanciato la palla nell’angolo della speculazione edilizia. Quell’Italia lì, però, era assai diversa da quella attuale. Allora, nel secondo dopoguerra, i palazzinari si sfregavano le mani con il boom economico. L’edilizia era acrobatica, la politica faceva acrobazie pur di accontentarla. Oggi ci si gratta la pancia, quando non interviene in soccorso il superbonus. Gli affari latitano, il potere d’acquisto delle famiglie è ostaggio della crisi finanziaria. A Taranto quindi, è ragionevole pensare, avvenga altro. L’assenza di programmazione e gli appetiti bulimici di alcuni proprietari terrieri spiegherebbero il fenomeno. Consumiamo suolo perché non sappiamo operare diversamente. Si utilizza la rendita come reddito permanente. Altro, la nostra imprenditoria, sa farlo poco. Mi fa sorridere il dibattito odierno quando pone l’accento sui costi della transizione ecologica. Il problema è l’esatto contrario. Sono i nostri ritardi, l’immobilismo, la conservazione bigotta di specifici schemi culturali, il mancato aggancio alla modernità a costare tanto. A rendere poco. E fruttare unicamente ai soliti noti. Taranto, con i suoi cattivi esempi, sta a dimostrarlo.